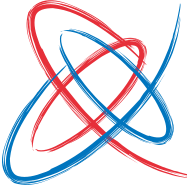A partire da inizio agosto 2021 i talebani afghani sono riusciti ad entrare in circa 26 capoluoghi in province chiave nel nord (Baghlan, Badakhshan, Takhar, Kunduz, Samangan, Jawzjan e Sar-e-Paul e Balk), nell’ovest (Badghis, Ghor, Herat, Farah, Nimruz), nel sud (Helmand, Kandahar, Zabul, Uruzugan) e nell’est (Ghazni, Logar, Paktika, Khost, Nangharar, Kunar e Laghman), fino ad arrivare a Kabul nella giornata del 15 agosto.
L’ingresso dei talebani a Kabul ha segnato una nuova fase nella storia del Paese e dell’Asia Centrale. A poche settimane dal definitivo ritiro delle truppe internazionali, il gruppo guidato da Hibatullah Akhunzdada ha innalzato la propria bandiera sul palazzo presidenziale ed ha annunciato l’intenzione di ripristinare l’Emirato Islamico d’Afghanistan. La conquista di Kabul è giunta al culmine di una campagna militare in stile “blitzkrieg”, compiuta nel corso dei primi dieci giorni di agosto, che ha consentito il controllo di circa il 70% del territorio nazionale. Nel corso della loro inarrestabile avanzata, i talebani sono stati in grado di stringere una serie di accordi con capi locali e gruppi di potere, anche al di là delle roccaforti nel sud e nell’est da sempre vicine alle istanze del movimento. Nel momento in cui il ritiro delle Forze straniere dal Paese ha creato una fase di incertezza sulle effettive possibilità di tenuta del governo centrale, i talebani sono riusciti a trovare diversi interlocutori disposti ad appoggiare la propria avanzata o a non interferire nelle operazioni militari, probabilmente in cambio di potere o concessioni finanziarie.
Questa ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla facilità con cui i guerriglieri islamici sono riusciti a penetrare in aree storicamente simbolo della resistenza anti-talebana, come Herat e Mazar-e-Sharif.
Dopo la partenza delle truppe occidentali entra nel “gran gioco” afghano il pragmatismo non egemonico di Pechino. L’incontro del ministro degli Esteri Wang Yi con i supremi capi talebani, avvenuto pochi giorni fa nella capitale cinese, potrebbe essere un segnale importante. Dopo l’infausto abbandono di Kabul da parte degli americani e dei loro alleati occidentali, il 15 agosto è stata scritta una pagina di storia, non solo afghana. A Doha, capitale dello Stato peninsulare del Qatar, gli emissari di Washington avevano concordato con i talebani il ritiro ordinato dell’Occidente, ma la fuga precipitosa con gli elicotteri in stile Saigon 1975 ha fatto sprofondare l’amministrazione Biden nell’ imbarazzo: infatti, una cosa è ritirarsi nei tempi e nei modi di un accordo, un’altra è essere travolti nell’arco di tre giorni, quando appena il giorno prima il Presidente degli Stati Uniti aveva detto che ci sarebbero voluti dei mesi. E invece i talebani si celavano dietro le colline di Kabul e in meno di dieci ore si sono presi la capitale dopo avere “liberato” le 25 città più importanti del paese. In questo scenario, la Repubblica Popolare Cinese è diventata improvvisamente l’attore principale sullo scacchiere dell’inquieto mondo islamico dell’Asia Centrale. In particolare, dopo aver fatto comprendere ai talebani che non accetterà turbative terroristiche, irredentiste o separatiste nell’area (chiaro il riferimento agli Uighuri), Pechino si è resa disponibile a collaborare alla modernizzazione dell’Afghanistan, coinvolgendolo nel grande progetto infrastrutturale della Via della Seta (BRI). Con la sua politica di non ingerenza e di collaborazione economica la Cina si presenta come il nuovo asse del polo centro-asiatico per i paesi islamici, che si affacciano sul suo rissoso e turbolento confine centroasiatico.
Se il nuovo scenario delineatosi dovesse trovare quell’equilibrio che l’Occidente in un ventennio non ha saputo realizzare e tanto meno garantire, il ruolo della Repubblica Popolare Cinese diventerebbe quello che essa sta accarezzando pazientemente da tempo, indifferente alle crescenti minacce atlantiche. Dopo la presa di Kabul, gli USA sembrano avere qualche problema in più cui badare.

I mass media americani danno tutti la colpa della vittoria dei talebani alla corruzione incorreggibile dell’Afghanistan. Ma l’entità del fallimento degli Stati Uniti in Afghanistan è mozzafiato. Non è un fallimento dei Democratici o dei Repubblicani, ma un fallimento di tutta la cultura politica americana, che si riflette nella mancanza di interesse da parte dei politici statunitensi nel comprendere le società diverse dalla loro.
Quasi tutti i moderni interventi militari statunitensi nel mondo in via di sviluppo sono andati male. È difficile pensare a un’eccezione a partire dalla guerra di Corea. Negli anni ’60 e nella prima metà degli anni ’70, gli Stati Uniti hanno combattuto in Indocina – Vietnam, Laos e Cambogia – ritirandosi alla fine sconfitti dopo un decennio di grottesche carneficine. Il presidente Lyndon B. Johnson, un democratico, e il suo successore, il repubblicano Richard Nixon, ne hanno condiviso la colpa.
Più o meno negli stessi anni, gli Stati Uniti hanno insediato dittatori in tutta l’America Latina e in alcune parti dell’Africa, con conseguenze disastrose che sono durate decenni. Si pensi alla dittatura di Mobutu nella Repubblica Democratica del Congo dopo l’assassinio di Patrice Lumumba, appoggiato dalla CIA all’inizio del 1961, o alla micidiale giunta militare del generale Augusto Pinochet in Cile dopo il rovesciamento di Salvador Allende sostenuto dagli Stati Uniti nel 1973.
Negli anni ’80, gli Stati Uniti sotto Ronald Reagan hanno devastato l’America Centrale in guerre per procura per prevenire o rovesciare i governi di sinistra. E quella regione non è ancora guarita. Dal 1979, il Medio Oriente e l’Asia occidentale hanno subìto il peso della follia e della crudeltà della politica estera statunitense. La guerra in Afghanistan è iniziata 42 anni fa, nel 1979, quando l’amministrazione del presidente Jimmy Carter sostenne segretamente i jihadisti islamici per combattere il regime sostenuto dai sovietici. Ben presto, i mujahedin sostenuti dalla CIA contribuirono a provocare un’invasione sovietica, intrappolando l’Unione Sovietica in un conflitto debilitante, mentre spinsero l’Afghanistan in quella che divenne una spirale di violenza e spargimento di sangue lunga quarant’anni.
In tutta la regione, la politica estera degli Stati Uniti ha prodotto un crescente caos. In risposta al rovesciamento dello Scià di Persia nel 1979 (un altro dittatore installato dagli Stati Uniti), l’amministrazione Reagan armò il dittatore iracheno Saddam Hussein nella sua guerra alla neonata Repubblica islamica dell’Iran. Ne seguì uno spargimento di sangue di massa e una guerra chimica sostenuta dagli Stati Uniti. Questo episodio sanguinoso fu seguito dall’invasione del Kuwait da parte di Saddam e poi da due Guerre del Golfo guidate dagli Stati Uniti, nel 1990 e nel 2003.
L’ultimo ciclo della tragedia afghana iniziò nel 2001. Appena un mese dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, il presidente George W. Bush ordinò un’invasione guidata dagli Stati Uniti per rovesciare i jihadisti islamici che gli Stati Uniti avevano appoggiato in precedenza. Il suo successore democratico, il presidente Barack Obama, non solo continuò la guerra e aggiunse un maggior numero di truppe, ma ordinò anche alla CIA di lavorare con l’Arabia Saudita per rovesciare il presidente siriano Bashar al-Assad, causando la feroce guerra civile siriana che continua ancora oggi. Come se non bastasse, Obama ordinò alla NATO di estromettere il leader libico Muammar Gheddafi, provocando un decennio di instabilità in quel paese e nei suoi vicini (incluso il Mali, che è stato destabilizzato dall’afflusso di combattenti e armi dalla Libia).
Ciò che questi casi hanno in comune non è solo il fallimento della politica. Alla base di tutti questi interventi c’è la convinzione da parte dell’establishment che gestisce la politica estera statunitense che la soluzione a ogni sfida politica sia l’intervento militare o la destabilizzazione sostenuta dalla CIA.
Tale convinzione ci riferisce del totale disprezzo da parte dell’élite statunitense nei confronti del desiderio di altri paesi di sfuggire alla povertà opprimente. La maggior parte degli interventi militari statunitensi e della CIA si sono verificati in paesi che stavano lottando per superare una grave crisi economica.
Anche uno sguardo superficiale alla spesa americana in Afghanistan rivela la stupidità della sua politica in quel paese. Secondo un recente rapporto dell’Ispettorato generale speciale per la ricostruzione dell’Afghanistan, gli Stati Uniti hanno investito circa 946 miliardi di dollari tra il 2001 e il 2021.
Di quei 946 miliardi di dollari, ben 816 miliardi di dollari, ovvero l’86%, sono andati in spese militari per le truppe statunitensi. E il popolo afghano ha visto poco dei restanti 130 miliardi di dollari, di cui 83 miliardi destinati alle forze di sicurezza afgane. Altri 10 miliardi di dollari circa sono stati spesi per operazioni di lotta al narcotraffico, mentre 15 miliardi di dollari sono stati destinati alle agenzie statunitensi che operavano in Afghanistan. Ciò ha lasciato la misera somma di 21 miliardi di dollari in finanziamenti per il “sostegno economico”. Eppure, anche gran parte di questa cifra ha fatto poco o niente per lo sviluppo del paese.
In breve, meno del 2% della spesa statunitense per l’Afghanistan, e probabilmente molto meno del 2%, ha raggiunto il popolo afghano sotto forma di infrastrutture di base o servizi per la riduzione della povertà. Gli Stati Uniti avrebbero potuto investire in acqua pulita e servizi igienico-sanitari, edifici scolastici, cliniche, connettività digitale, attrezzature agricole, programmi nutrizionali e molti altri programmi per sollevare il paese dalla privazione economica. Invece, lasciano, insieme agli altri partner occidentali, un paese con un’aspettativa di vita di 63 anni, un tasso di mortalità materna di 638 ogni 100.000 nascite e un tasso di arresto della crescita infantile del 38%.
Gli Stati Uniti non avrebbero mai dovuto intervenire militarmente in Afghanistan, né nel 1979, né nel 2001, né nei 20 anni successivi. Ma una volta lì, gli Stati Uniti avrebbero potuto e dovuto promuovere un Afghanistan più stabile e prospero investendo in salute materna, scuole, acqua potabile, nutrizione e simili. Tali investimenti umani – finanziati soprattutto insieme ad altri paesi e attraverso istituzioni come la Banca asiatica di sviluppo – avrebbero contribuito a porre fine allo spargimento di sangue in Afghanistan e in altre regioni impoverite, prevenendo guerre future.
All’indomani della caduta di Kabul, i mass media statunitensi, come prevedibile, danno la colpa del fallimento degli Stati Uniti all’incorreggibile corruzione dell’Afghanistan. La mancanza di autocoscienza americana è sorprendente. Non sorprende che dopo trilioni di dollari spesi per le guerre in Iraq, Siria, Libia e oltre, gli Stati Uniti non abbiano nulla da mostrare per i loro sforzi se non un paese insanguinato e in mano ai maggiori narcotrafficanti del mondo.
di Carlo Marino
#carlomarinoeuropeannewsagency