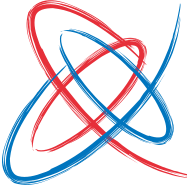Solo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso fu avviata un’analisi approfondita circa l’utilizzo, per lo più in funzione strumentale e propagandistica, del mito dell’antica Roma da parte del regime fascista, a cominciare dallo stesso Benito Mussolini.
Tra i diversi studiosi che se ne sono occupati, ricordiamo Luciano Canfora Andrea Guardina ed Emilio Gentile; Renzo De Felice fu il primo a trattare diffusamente dei meccanismi del consenso messi in atto dal regime, che fecero ampio ricorso, tra l’altro, ai miti della romanità per celebrare il fascismo e il suo capo. Fu proprio De Felice a riferire che, nel corso della lunga intervista a Margherita Sarfatti, intellettuale ebrea e per diversi anni amante ed ispiratrice di Mussolini, fosse emerso come: “Margherita aveva un vero e proprio culto per la romanità che probabilmente instillò nel futuro Duce, il quale abbinò i fasti del regime a quelli dell’antica Roma”.
La tesi di Canfora è che il regime avrebbe utilizzato il mito romano per legittimare il carattere antidemocratico del fascismo, esaltare il concetto di disciplina e l’imperialismo coloniale, celebrare il mito della grande potenza e la figura del capo carismatico. A dirla tutta, la propaganda fascista non fece ricorso solo a miti romani, ma anche rinascimentali o risorgimentali, presentandosi come l’erede e il continuatore della rinascita nazionale; perfino elementi stranieri o esotici, come il fez (copricapo di origine turca) utilizzato nelle divise di regime o il motto di evviva (usato per la prima volta dai legionari dannunziani) di “Eia! Eia! Alalà!”, gridato dalle milizie durante le celebrazioni ufficiali, dimostrano la flessibilità del fascismo nel ricorso a formule o mitologie utili alle proprie esigenze. Lo stesso potrebbe dirsi circa la decisione di Mussolini, dopo la conquista dell’Etiopia e l’avvicinamento a Hitler, di introdurre nelle parate militari il passo dell’oca tedesco, ribattezzato romano, che in realtà con l’antichità non aveva nulla a che vedere e che venne sempre percepito estraneo alla tradizione italiana. Come vedremo meglio più avanti, in questi e tanti altri casi si trattò di mere strumentalizzazioni, se non vere e proprie distorsioni della realtà storica, funzionali alla propaganda e agli assetti di potere dello stato fascista. Tuttavia, come ha osservato Giardina, constatare ciò non significa pensare che il fascismo (o lo stesso Mussolini) pensassero ad una sorta di restaurazione o ritorno al passato: al contrario, il mito dell’antichità aveva lo scopo dichiarato di progettare un mondo nuovo e moderno, ispirato alla potenza e alla disciplina di presunta derivazione romana. Lo stesso impiego della propaganda martellante, del resto, con l’ampio ricorso ai più moderni mezzi di comunicazione di massa, dimostra fin troppo bene come il fascismo non aspirasse nel modo più assoluto ad un ritorno ai tempi che furono: semplicemente cercava di trarre dal passato una sorta di legittimazione storica e vi ricercava uno strumento di pressione sulla società per operare una serie di cambiamenti. Il regime, mano a mano che consolidava il suo potere, mirava alla creazione dello stato totalitario, facendo del fascismo una sorta di nuova religione politica della nazione, all’interno della quale l’individuo singolo contava poco o nulla rispetto alla collettività: in altre parole, l’individuo è nulla e lo stato è tutto; per rafforzare questa visione si fece ampio ricorso alla romanità, presentata come un modello di disciplina e coesione sociale (che poi lo fosse stato per davvero non contava più di tanto). Lo stesso Giardina scrive come sia esistito un: “carattere creativo, e non solo imitativo, delle visioni romane del fascismo”, specificando che “la romanità fascista non era un modello fossilizzato, da riprodurre con una sensibilità da antiquari, ma una realtà in movimento, un processo in perenne trasformazione”; alle medesime conclusioni arriva Gentile, quando afferma che: “L’italiano nuovo del fascismo doveva essere integralmente inserito nella società industriale e tecnologica, controllata dallo Stato totalitario per essere posta a servizio della grandezza nazionale. Per il fascismo, l’italiano nuovo e la nuova Italia dovevano essere il prodotto originale e inedito dell’esperimento totalitario; il romano della modernità era l’uomo collettivo organizzato, un individuo assorbito nella società di massa della comunità totalitaria attraverso l’organizzazione del partito unico: era il “cittadino soldato”, interamente dedito, anima e corpo, allo Stato fascista, lanciato alla conquista del futuro, con tutti i mezzi che la modernizzazione metteva a disposizione per una politica di grandezza e di potenza”. In pratica, quello che emerge è un culto della romanità che, senza nulla togliere alle finalità propagandistiche, voleva portare a forgiare l’uomo “nuovo”, rinnovando profondamente la società, specie rispetto al periodo liberale postunitario. Il fascismo diffuse in modo pervasivo il mito della cosiddetta terza Roma, dopo quella dei Cesari e dei Papi, che come le prime due avrebbe dovuto avere una vocazione universalistica, che trascendesse i confini nazionali, con l’obiettivo di proiettare il paese verso un ruolo di grandezza e potenza, circa il quale il mito della romanità si prestava perfettamente allo scopo; certo non l’unico, esso si rivelò assai utile per giustificare una serie di scelte politiche e ricercare il consenso delle masse, perfino quando il regime – con decisioni repentine e/o veri e propri giri di valzer – modificava radicalmente la sua politica (come avvenne, ad esempio, col varo delle leggi razziali). Per quanto suoni paradossale, persino le più feroci dittature cercano un certo margine di consenso, per preservare e perpetuare il proprio potere: il fascismo non fu da meno. Mussolini, non dimentichiamolo mai, veniva dal mondo del sindacalismo rivoluzionario e del giornalismo, per cui era pienamente consapevole dell’importanza del consenso: pur manifestando nel corso di tutta la sua esperienza politica una grande flessibilità e una certa tendenza ai mutamenti repentini, si preoccupò sempre di giustificare le sue scelte di fronte all’opinione pubblica. Al proposito di mutamenti, la stessa opinione del futuro duce nei riguardi della città di Roma, come del mito dell’antichità, sono tutt’altro che univoche o costanti nel tempo. Leggendo il programma dei fasci di combattimento del 1919 non troviamo il benché minimo cenno alla Roma dei cesari. Tornando ancora più indietro nel tempo, Mussolini più volte si espresse in toni sprezzanti o poco lusinghieri sulla capitale, come quando, ancora socialista rivoluzionario, la definiva “città parassitaria di affittacamere, di lustrascarpe, di prostitute, di preti e di burocrati”. Nel maggio del 1922, pochi mesi prima della marcia su Roma, scrisse sul Popolo d’Italia, il quotidiano da lui fondato e diretto dal 1914, di una città infettata dalla più predace e parassitaria borghesia, sede dei principali giornali antifascisti. Nell’esprimere giudizi negativi sulla capitale, del resto, Mussolini era in buona compagnia: negli stessi anni il comunista Antonio Gramsci non si dimostrava più tenero, parlando di una città priva di qualunque funzione nella vita sociale italiana e destinata a subire la dura legge dello stato operaio contro i parassiti. Queste dichiarazioni si poneva in linea di continuità con un certo sentimento antiromano diffuso in varie parti d’Italia dopo il 1861: pur coi dovuti distinguo, Roma era vista come la rappresentazione di una serie di elementi negativi che avevano caratterizzato il nuovo stato unitario – accentratore, burocratico, trasformista, mediocre – contrapposta alla vera capitale morale, Milano, nella quale lo stesso Mussolini visse prima di assumere la guida del governo. Autorevoli letterati come Giosuè Carducci o Gabriele d’Annunzio celebravano, è vero, i fasti dell’antichità, ma li contrapponevano nettamente alla mediocrità della capitale dei giorni nostri. All’avversione piuttosto diffusa nel sentimento popolare, i fascisti (e lo stesso Mussolini) aggiungevano quella nei confronti dell’Italia liberale e borghese, incarnata da Roma, che il fascismo voleva (almeno a parole) abbattere. Vista la tendenza tutta italiana al trasformismo, specie quando si entra nella stanza dei bottoni, anche i sentimenti antiborghesi del fascismo ebbero, col tempo, la tendenza a scemare. Una volta preso il potere, favorita dal sostegno di industriali e agrari, furono tanti gli esponenti dei ceti medi che – per convinzione o per convenienza – aderirono al fascismo, contribuendo a quell’imborghesimento del movimento contro il quale si scaglierà il Duce, specie a partire dalla seconda metà degli anni Trenta, con una serie di misure – l’abolizione del “lei” o della stretta di mano, la diffusione delle uniformi, e via dicendo – che non incideranno più di tanto sugli assetti sociali, tanto che Indro Montanelli scriverà che il fascismo, archiviata la fase della rivoluzione, era divenuto amministrazione, con al centro proprio la città di Roma. Mussolini era stato più volte nella capitale, ma prese a risiederci con una certa assiduità a partire dal 1921, quando per la prima volta venne eletto deputato. In questa fase storica, a quanto pare, maturò un cambio di approccio verso la città eterna, tanto che Mussolini stesso parlerà della sua riconciliazione con la capitale; riguardo la sincerità di queste parole sarebbe arduo esprimersi. Una cosa, però, è certa. Mussolini non abbandonò mai l’idea di fare della capitale borghese e burocratica, in precedenza disprezzata e criticata, una città nuova, degna dei fasti del periodo romano e imperiale. La capitale, in pratica, doveva trasformarsi nel simbolo del nuovo avvenire di grandezza e potenza sognato dal fascismo, il quale, divenuto regime, si diede un gran daffare per realizzare tale obiettivo, anche in senso visivo e architettonico, ricorrendo ampiamente alle vestigia e miti dell’antichità. Come in tante altre cose, Mussolini non s’inventò nulla di suo: l’idea di usare il mito della romanità per creare una società nuova, guerriera e imperialista, circolava da due decenni. Ne era stati fautori, tra gli altri, il nazionalista Enrico Corradini e il poeta soldato Gabriele d’Annunzio. Il duce si impossessò, semplicemente, di queste dottrine, facendone parte integrante della retorica del movimento (poi partito e regime) fascista. Mussolini non ebbe difficoltà a mettere da parte i toni sprezzanti utilizzati in passato contro Roma: fu lui stesso a chiarire che l’iniziale avversione era intesa contro la città “pettegola e nemica”, non certo verso la città eterna, che il fascismo si sarebbe impegnato a far rinascere, trasformando la Roma liberale e borghese in quella imperiale e universale. Il 9 novembre 1921 si tenne a Roma il congresso che avrebbe trasformato il movimento in partito, un’occasione nella quale – forse per l’ultima volta ufficialmente – si sarebbe palesato un certo disagio tra i fascisti romani e quelli venuti da fuori, mentre gli abitanti della capitale si dimostrarono piuttosto freddi nei riguardi del fascismo; era una fase storica nella quale il movimento era molto più radicato nel centro nord, che nella capitale, ma Mussolini colse l’occasione per avviare la riconciliazione tra fascismo e città eterna. Il 21 aprile dello stesso anno aveva annunziato la celebrazione del Natale di Roma, che diverrà una ricorrenza ufficiale durante il ventennio, rimpiazzando la festività del primo maggio (contestualmente abolita), con una sfilata della milizia fascista per le vie della capitale. Molto significative le parole pronunciate nell’occasione dal futuro dittatore, che per la prima volta faceva esplicito riferimento al concetto di razza (tanto che il discorso sarà ripreso quando il regime abbraccerà l’antisemitismo): “Celebrare il Natale di Roma significa celebrare il nostro tipo di civiltà, significa esaltare la nostra storia, e la nostra razza, significa poggiare fermamente sul passato per meglio slanciarsi verso l’avvenire. Roma e Italia sono due termini inscindibili. […] Roma è il nostro punto di partenza e di riferimento, il nostro simbolo, o se si vuole, il nostro mito. […] Molto di quel che fu lo spirito immortale di Roma risorge nel fascismo: romano è il Littorio, romana è la nostra organizzazione di combattimento, romano è il nostro orgoglio e il nostro coraggio: Civis romanus sum”. Gli farà eco Pietro De Francisci, uno dei più autorevoli romanisti dell’epoca: “Ed è conoscenza fatalmente soggetta all’influenza di questa (o almeno alla coscienza che di questa si possegga): giacché ogni civiltà propende all’esaltazione di quei valori storici che rispondono ai suoi fini ed ha per base una visione sintetica che tende ad armonizzare il passato e il presente con quel futuro verso il quale la volontà costruttrice dirige la sua azione.” Mussolini sfruttò ampiamente il mito dell’antica Roma, prima e dopo il congresso del ’21, per cementare un movimento tutt’altro che unitario agli inizi degli anni Venti e per combattere gli avversari nemici politici (i partiti borghesi e della sinistra), contro i quali il movimento fascista – che si presentava sempre più come erede della romanità e fautore della rinascita nazionale – rivendicava il monopolio della cosa pubblica (cosa che fece tra il ’25 e il ’26). Una volta conquistato il potere, il fascismo adotterà un calendario parallelo, espresso in numeri romani, che indicava l’era fascista partendo dal 1922, destinato ad affiancare quello ordinario nelle celebrazioni e pubblicazioni. Mussolini non perse tempo nel progetto di edificare, anche e soprattutto materialmente, la nuova Roma. Il 31 dicembre del 1925 si insediò il primo governatore di Roma, che prese il posto dell’amministrazione comunale elettiva, e nell’occasione Mussolini rivendicò al fascismo il merito di stare restituendo a Roma il prestigio e ruolo di capitale d’Italia, mettendo definitivamente a tacere ogni avversione verso la capitale, ancora latente in certe fazioni interne al partito. In quel momento, difatti, Mussolini aveva già messo in cantiere i progetti per una profonda revisione urbanistica della capitale, che negli anni a venire ne avrebbero completamente trasformato il centro storico, rimuovendo per sempre caseggiati e quartieri simbolo della città medievale e rinascimentale, per “liberare” – così si espresse il regime – i tanti monumenti dell’antichità; i nuovi programmi urbanistici vennero formalizzati nel grande piano regolatore approvato il 18 marzo 1932. La città contemporanea, secondo le parole scritte nel 1938 dallo studioso Ciarlantani, erede di quella antica, doveva possedere: «lo spirito della potenza creatrice di Roma che nella famiglia, nella religione, nell’educazione militare, nelle leggi seppe infondere un sacro rispetto al principio della subordinazione del singolo alla collettività». Se già nel 1923 presero avvio una serie di operazioni che finiranno per distruggere gran parte del centro storico di Roma, nel 1924 saranno le abitazioni edificate sopra o in prossimità dei mercati e del foro di Traiano, di Augusto e di Cesare, collocati sul lato sinistro dell’altare della patria, ad essere demolite. Negli anni seguenti furono avviati i lavori nell’attuale piazza di Torre Argentina e presso il Teatro di Marcello, dove Mussolini in persona, simbolicamente, diede il primo colpo di piccone per i lavori di recupero. Alla fine degli anni Venti vennero rasi al suolo i quartieri medievali che si trovavano alla destra dell’altare della patria, per poi iniziare coi lavori per la realizzazione della nuova via dell’Impero (oggi via dei Fori Imperiali), che avrebbe collegato piazza Venezia – sede dal 1929 degli uffici di Mussolini – al Colosseo, cancellando, tra gli altri, il quartiere cinquecentesco costruito sui fori di Augusto e Nerva e numerose strade preesistenti (come via san Lorenzo o Del Lauro o Cremona), liberando un’area di circa 40mila metri quadrati. Tra le altre opere la nuova via del mare, frutto della demolizione di case e chiese situate tra l’Ara Coeli, piazza San Marco e le pendici del campidoglio, che avrebbe collegato la capitale al mare (lido di Ostia). Nel 1934 sarà recuperata l’area del circo massimo, destinata ad ospitare le mostre organizzate dal PNF. Ricordiamo che ulteriori lavori di demolizione interessarono il centro storico, dopo il Concordato del 1929, per aprire la nuova via della Conciliazione, che conduceva (e conduce) verso piazza San Pietro. Se qualcuno si chiedesse che fine fecero i cittadini – borghesi, artigiani, operai – che videro buttare giù (senza permesso) le loro case è presto detto: molti di loro furono trasferiti in grandi alloggi popolari presso il quartiere di Garbatella o in borgate costruite in fretta e furia nella periferia; furono circa 150mila le persone che si spostarono dal centro alle zone periferiche. Gran parte della vecchia Roma medievale e papalina finì per scomparire per sempre, per lasciare spazio alla nuova capitale voluta da Mussolini. I grandi lavori e l’aumento di enti e istituzioni pubbliche contribuirono negli anni Venti e Trenta ad un incremento significativo della popolazione capitolina, cresciuta di circa 800mila unità (+ 74 per cento) solo tra il 1921 e il 1936, mentre la distribuzione degli abitanti acutizzava le divisioni sociali: borghesia e ceti medi risiedevano nel centro nord, le classi popolari in periferia e sul lato meridionale. Non mancarono, nonostante tutto, i critici della furia demolitrice e revisionista, che, come detto, cancellò l’urbanistica medievale e rinascimentale del centro romano: tra gli altri l’ex ministro dell’Istruzione Pietro Fedele, ma Mussolini non prestò nessuna attenzione ai detrattori, tirando dritto per la sua strada. Un ruolo relativamente minore per il culto della romanità ebbe, invece, l’industria cinematografica. Sebbene definita da Mussolini l’arma più forte (intesa come propaganda), le pellicole dedicate all’antichità non furono numerose ed ebbero un successo molto limitato, a cominciare dal kolossal Scipione l’Africano, diretto da Carmine Gallone, dedicato alla storia della seconda guerra punica, incentrato sullo scontro tra la civiltà occidentale e quella africana di Cartagine. Il film, che mirava a creare un parallelo tra Mussolini e l’antico condottiero romano che vinse i cartaginesi, non ripagò le aspettative e gli ingenti investimenti per la sua realizzazione, mentre molti attori, a cominciare dal protagonista, non si dimostrarono all’altezza. Si era nel periodo dell’apogeo del regime, subito dopo la guerra d’Etiopia, che permise a Mussolini – in occasione delle celebrazioni per la vittoria – di dichiarare dinanzi alla folla riunita sotto il balcone di Palazzo Venezia, la sera del 9 maggio 1936, di proclamare la rinascita dell’impero sui “colli fatali” di Roma; per la cronaca il balcone teatro delle grandi adunate oceaniche di regime era all’epoca contornato dei fasci littori, che sarebbero stati rimossi totalmente solo ai primi del nuovo millennio. L’impresa africana rappresentò indubbiamente l’apogeo del regime e dello stesso Mussolini. La sua figura, sempre più circondata di tratti mitici e simbolici, venne celebrata in occasione della mostra augustea della romanità, inaugurata a Roma il 23 settembre 1937; nel 1930 e nel 1935 ce n’erano state altre dedicate a Virgilio e Orazio, ma nessuna delle due aveva avuto tanta enfasi. Non stupiscono, nel clima celebrativo di quegli anni, le parole del l’archeologo Giulio Quirino Giglioli, direttore della mostra, che inaugurando l’esposizione parlò del duce come del «novello Augusto della risorta Italia imperiale» o di «un genuino discendente di sangue degli antichi romani». E non fu certo l’unico che in questa sorta di gara per incensare il dittatore, stese improbabili paragoni tra Mussolini e figure storiche di Cesare o Ottaviano, pur con tutte le riserve che si potrebbero esprimere circa la sincerità (e l’opportunismo) di queste prese di posizione. Nell’ambito delle celebrazioni per il bimillenario della nascita di Augusto, avvenne l’inaugurazione dell’Ara Pacis Augustae, protetta dalla teca dell’architetto Vittorio Morpurgo, avvenuta il 23 settembre 1938 alla presenza di Mussolini. Era evidente l’intento di identificare sempre di più il duce col primo imperatore di Roma, indicato come il creatore del nuovo ordine universale fondato sull’impero; non a caso il capo del governo, per deliberazione del gran Consiglio del fascismo, verrà celebrato negli anni a venire come il “fondatore dell’impero”. Nei giorni successivi alla vittoria, Mussolini si era recato in Campidoglio per deporvi l’alloro dei fasci, come (pare) avesse fatto Augusto, dando ordine di edificare un gigantesco obelisco di 24 metri dinanzi al ministero dell’Africa italiana (dove oggi ha sede la FAO). La conquista della nuova colonia, presentata dalla propaganda come la rinascita imperiale, rappresentò, persino per i critici del fascismo, il momento di massimo consenso per il regime e per il suo capo. Portata a termine l’impresa africana, fu varato un nuovo e importante progetto urbanistico: la costruzione di una nuova città nella periferia romana, in vista della candidatura della capitale come sede dell’esposizione universale del 1942; i lavori iniziati nel 1937 furono interrotti a causa del conflitto tra il ’41 e il ’42. Il nuovo quartiere chiamato E42 (l’attuale EUR), acronimo per esposizione universale 1942, avrebbe dovuto essere la rappresentazione architettonica, simbolica e funzionale di una nuova concezione dell’uomo, della politica e dello Stato, divenendo un punto d’incontro tra passato e futuro, oltre che fungere da vetrina internazionale per il regime. Lo stesso stile architettonico neoclassico e fascista mirava a unire antico e moderno. Un apposito ente pubblico, alle dirette dipendenze del capo del governo, fu incaricato della realizzazione del progetto. Il nuovo complesso si andava a congiungere col rinnovato centro storico e altre realizzazioni del regime (come il foro Mussolini, l’attuale foro Italico, situato nella parte nord tra il Tevere e le pendici di monte Mario, destinato ad accogliere le organizzazioni giovanili del regime) simboleggiando una sorta di continuità tra tutte le opere del regime; dall’altro lato andava verso Ostia e il mare, un’altra importante arteria di collegamento voluta dal fascismo. Nel 1939 fu collocato nell’atrio del Palazzo degli Uffici dell’Eur il bassorilievo, realizzato da Publio Morbiducci: l’opera riprende episodi della Roma antica, partendo dalla fondazione dell’Urbe, per arrivare alla rappresentazione di un Mussolini a cavallo, acclamato da due fanciulli. Un evidente e goffo tentativo, ispirato alla colonna di Traiano, per significare la continuità tra antichità e fascismo. Gli architetti e progettisti che curarono l’edificazione dei nuovi complessi (il responsabile fu Marcello Piacentini), tra i quali il palazzo dei Congressi o quello della Civiltà italiana, si ispirarono a criteri di monumentalità e di grandiosità, conciliando il principio razionale con quello estetico; a parte Piacentini, molti gli artisti e architetti impegnati nei grandi lavori di rifacimento della capitale, tra i quali ricordiamo Enrico Del Debbio, Mario De Renzi, Adalberto Libera, Gaetano Minnucci, Luigi Moretti, Giuseppe Pagano, Mario Ridolfi, Mario Sironi, i quali, pur aderendo ai progetti e alle idee di Mussolini – per convinzione o per convenienza –certamente diedero un importante contributo dal punto di vista professionale e tecnico. Ancora oggi molti di quegli edifici sono in piedi, ospitando prevalentemente musei, uffici e sedi istituzionali di enti pubblici o istituti bancari, mentre alcuni simboli troppo apertamente ispirati al regime vennero dissimulati: è il caso del genio del fascismo, divenuto genio dello sport nel 1946, statua – sita al palazzo degli uffici – rappresentante un atleta, alla quale fu aggiunto un guantone da lottatore per celare il saluto romano; ancora oggi sono presenti frasi del repertorio mussoliniano, come quella del palazzo della Civiltà che definiva gli italiani “Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori.” La campagna d’Africa segnò il punto più alto del regime, ma anche l’inizio della parabola discendente. Come accennavamo, dopo averle a lungo criticate, il fascismo promulgava di lì a poco la legislazione razziale, sgradita alla maggioranza degli italiani e alle gerarchie ecclesiastiche. Le ricercate (e goffe) giustificazioni mutuate dall’antichità per questo nuovo indirizzo politico non convinsero nessuno, e le nuove leggi furono percepite dal popolo italiano per quello che erano: un elemento estraneo al regime, come alle stesse tradizioni latine e fasciste. Al contrario, come sappiamo, la dottrina razziale fu sempre parte integrante dell’ideologia nazista, tanto che nella dottrina hitleriana il ruolo dell’antica Roma fu sempre molto marginale, se non per alcuni aspetti (ad esempio lo stato accentrato) che si confacevano ai fini politici del Fuhrer. Se pure in alcuni complessi architettonici voluti dal regime nazista possono vedersi elementi di romanità (per esempio il palazzo dello sport di Berlino o l’arena dei convegni di Norimberga), nulla di paragonabile ai progetti fascisti venne messo in atto come ispirato alla romanità. I lavori di rinnovamento edilizio e urbanistico non interessarono solo la capitale. Nel quadro della battaglia del grano per l’autosufficienza nazionale nella produzione cerealicola, che condussero alle grandi opere di bonifica (come l’agro pontino), i nuovi agricoltori furono chiamati coloni o veli del grano, dal nome dei soldati leggeri – velites – dell’antica Roma. Le bonifiche diedero vita a molte delle cosiddette città nuove – Mussolinia (oggi Arborea), 1928; Littoria (oggi Latina), 1932; Sabaudia, 1934; Pontinia e Guidonia, 1935; Fertilia e Aprilia, 1936; Arsia, 1937; Carbonia, Torviscosa e Pomezia, 1938; Pozzo Littorio, 1940 – i cui nomi spesso riecheggiavano quelli del regime o l’antichità. Le cerimonie ufficiali di inaugurazione – in diversi casi con la partecipazione di Mussolini – richiamavano quelle di Roma, con l’utilizzo dell’aratro col quale, secondo la leggenda, Romolo avrebbe tracciato i confini della sua città. Perfino sulle origini familiari di Mussolini i retori del regime trovarono dei legami con l’Urbe, ad esempio quando si disse che il duce era nato in terra di Romagna (precisamente a Predappio) da una famiglia discendente dai coloni romani insediatisi lì nel secondo secolo a. C. E se non bastavano i propagandisti interni, parole altisonanti e foriere di richiamo alla romanità le ritroviamo – per lo meno fin quando non cambiarono idea – in bocca a personaggi del calibro di Winston Churchill, che dichiarò di vedere in Mussolini un genio romano e il più grande legislatore vigente. A tal proposito, un altro terreno sul quale gli studiosi ed esperti di materia, sostenitori del mito della romanità e fiancheggiatori del regime, si spesero non poco fu proprio quello del diritto. Occorre premettere che ancora oggi molte delle nostre normative civilistiche affondano le radici nell’ordinamento romano (pensiamo, per esempio, alle obbligazioni o alle successioni), ragion per cui fu relativamente facile spiegare una certa continuità, che indubbiamente è presente, tanto ancora oggi il diritto romano viene studiato nel corso di laurea in Giurisprudenza. Ma di qui a dire che il diritto italiano sia integralmente debitore di quello antico ce ne passa. Tralasciando gli inevitabili aggiornamenti e l’evoluzione dei tempi e dei costumi, un’affermazione di questo tipo (come le sentenze che equiparavano le circolari del duce alle norme di legge) sarebbe perlomeno discutibile. In realtà, la stessa presentazione dell’assetto costituzionale voluto dal fascismo come una continuazione di quello romano andrebbe incontro a non poche critiche. Nel periodo repubblicano, del quale Mussolini volle riprendere soprattutto disciplina e rigore morale, un sistema guidato da un uomo solo non sarebbe stato concepibile. La rete di relazioni e il principio dell’elettività e della collegialità delle supreme magistrature, che coesistevano in un sistema di pesi e contrappesi, si sarebbe presentato incompatibile con la dittatura, mentre quest’ultima magistratura – prevista dall’ordinamento repubblicano in casi straordinari – era intesa come temporanea ed eccezionale. Il passaggio all’età imperiale non modificava, almeno nella forma, lo stato di cose, visto che lo stesso Augusto si presentò sempre (come i suoi successori) come il supremo garante e protettore della repubblica, perfino quando questa non esisteva più da tempo. E poi – per parlare di aspetti pratici – vi immaginereste mai Roma che si fa dettare la politica estera o quella bellica da un alleato (il riferimento è ovviamente alla Germania nazista)? Del resto, l’avvicinamento al Terzo Reich fu ostico da digerire per il popolo italiano. Stavolta il mito romano non si prestava allo scopo, tenuto conto che nel comune sentire (fatto storico non del tutto rispondente al vero) si attribuisce proprio ai germani il crollo dell’impero, senza contare che la comune radice latina rendeva assai difficile presentare, al contrario, come una nazione nemica la Francia: si trattava di palesi contraddizioni, che alla lunga nuocevano alla credibilità dei proclami ufficiali. Naturalmente il mito della romanità investì molti altri aspetti, urbanistica e diritto a parte. Così, ad esempio, a partire dal 1921, e sempre più dopo l’instaurazione della dittatura, la scelta dei nomi e delle gerarchie interne al partito, l’unica forza politica legalmente ammessa dal 1926, richiamavano quelli dell’antica Roma: i principi (o camice nere) e i riservisti (o triari) simboleggiavano il carattere militare del PNF, definito nello statuto (approvato con decreto reale) una milizia al servizio della nazione e dello stato fascista. Un richiamo alla romanità era presente nel nome scelto per l’esercito privato di regime, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN), che venne istituito per unificare (e controllare) le squadracce d’assalto fasciste, autrici delle spedizioni punitive dei primi anni Venti, contenendo allo stesso tempo l’intraprendenza e i desideri di poteri dei gerarchi locali (i cd. ras). L’assetto interno della MVSN era infarcito di nomi e simboli ispirati all’antica Roma: ogni squadra era comandata da un caposquadra (e da due vice capisquadra chiamati decurioni), quattro squadre formavano una centuria (comandata dal centurione), quattro di loro costituivano la coorte, guidata dal seniore, mentre nove coorti potevano confluire nella legione, comandata da un console. Precisiamo che nella maggior parte dei casi non esisteva nessuna corrispondenza tra questa struttura organizzativa e ruoli e funzioni delle stesse figure nell’antica Roma: nella migliore delle ipotesi c’era una completa distorsione – per esempio nell’antichità i consoli erano i massimi magistrati della repubblica – ma di questo nessuno si preoccupava più di tanto, visto che l’importante era il riferimento alla romanità. Naturalmente gli stessi simboli ufficiali del partito e del regime pescarono a piene mani nell’antica Roma, anche in tal caso con pesanti distorsioni storiche: i gagliardetti, le aquile e il fascio littorio fecero parte integrante della messinscena. Lo stesso termine “fascista”, poi gabellato come di origine romana, non nasceva assolutamente con questo significato, quanto piuttosto dall’associazionismo (fascio inteso come lega) proprio dei movimenti rivoluzionari e operai, come i fasci siciliani creati a fine ‘800 per contrastare il latifondismo o gli stessi fasci interventisti creati da Mussolini nel 1914. Si tratta di semplici dimostrazioni pratiche di come nomi o simboli di pretesa origine romana, nei fatti nulla avevano a che vedere l’antichità. Uno dei simboli più conosciuti è proprio quello del fascio littorio. Nel gennaio del 1923 furono coniate nuove monete da una e due lire che recavano da un lato l’effigie del Re e dall’altra il fascio, che nel 1925 fu collocato in tutti gli edifici pubblici e di partito, successivamente anche negli stemmi comunali; infine, dopo averlo proclamato nel 1927 emblema ufficiale dello stato, nell’aprile del 1929 i due fasci littori presero il posto dei leoni a sostegno dello scudo sabaudo, simbolo della dinastia regnante. Sotto il profilo grafico, l’emblema del regime (e dello stato) veniva rappresentato come un fascio di verghe con la scure a lato (simbolo dell’imperium, il potere politico e militare degli antichi magistrati romani), ma ancora una volta non si trattava di un’esclusiva del fascismo. Il fascio era già comparso durante la Rivoluzione francese e durante il risorgimento: l’unica innovazione apportato dal fascismo fu l’aggiunta della scure, che evocava il potere di comminare la pena capitale, simboleggiando la disciplina e supremazia del potere costituito. Autorevoli storici, antichisti e i romanisti, che durante il regime avranno molto spazio, si impegneranno tuttavia per avallare l’origine antica dei simboli adottati dal regime, ad esempio facendo leva sulle sculture romane dove compativa il fascio o sulla prassi, in uso presso i magistrati romani, di farsi accompagnare nelle parate dai lictores, che reggevano il fascio, simbolo dell’imperium (potere politico e militare). Lo stesso dicasi per il saluto romano, poi adottato da tutti i regimi ispirati a quello fascista: non sappiamo con certezza quale fosse il modo di salutare utilizzato dagli antichi nella quotidianità (la stretta di mano? L’abbraccio?), ma di sicuro il braccio teso non era tra questi. Il saluto romano, adottato durante il regime pure nelle pubbliche amministrazioni tra superiore e inferiore gerarchico, probabilmente ebbe tra gli antichi un utilizzo piuttosto limitato, come in occasioni particolari o nella prassi del saluto rivolto dall’imperatore ai suoi eserciti; il primo ad utilizzarlo, nel saluto rivolto ai suoi legionari, fu Gabriele D’Annunzio, al quale del resto Mussolini si ispirò in diverse circostanze (pensiamo solo alle grandi adunate oceaniche fiumane). Al proposito di nomi e rituali, Mussolini durante il regime fu chiamato Duce del fascismo. Il titolo, derivante dal latino Dux (comandante vittorioso o capo militare), non assunse carattere ufficiale sino alla fine degli anni Trenta, quando venne inserito negli atti ufficiali e nei testi di legge. L’origine, secondo le ricostruzioni più accreditate, non avrebbe però radici latine – presso questi popoli veniva utilizzato per indicare il monarca, in età tardo antica i capi militari nelle province – bensì sindacaliste rivoluzionarie; nel dizionario politico ufficiale del partito, curato dal glottologo Antonino Pagliaro, si legge che l’appellativo, già in uso in ambienti del sindacalismo rivoluzionario per indicare i leader, sarebbe stato utilizzato per Mussolini per la prima volta nel 1915 da Filippo Corridoni, lui stesso rivoluzionario e interventista, in una lettere indirizzata al futuro dittatore e suo commilitone; secondo altre ricostruzioni – meno parziali di questa – il titolo fu impiegato dal quotidiano la Tribuna addirittura nel 1904, parlando dell’espulsione dell’allora socialista Benito Mussolini da Ginevra. Invece, nelle ricostruzioni di regime, per suffragare le origini romane del titolo, venne spesso citato un passaggio delle Res Gestae di Augusto, dove si legge: «L’Italia intera di suo proprio volere mi giurò fedeltà e volle me come ‘duce’ nella guerra che vinsi ad Azio». Il titolo Dux sarebbe stato scelto da Margherita Sarfatti per la sua biografia di Mussolini (1926). L’appellativo “Duce” si rivelò assai utile nel sistema formalmente diarchico vigente in Italia, per attenuare la convivenza col Re, che sulla carta conservava il ruolo di vertice dello stato e di superiore del capo del Governo, ma che in realtà negli anni del regime si rassegnò a obbedirgli, fingendo di averlo ai suoi ordini. Al fine di creare un’apposita sede ufficiale per gli studi antichi funzionali alle esigenze del regime, nel marzo 1925 fu creato l’Istituto di studi romani, ente culturale con la finalità di «il senso storico della funzione esercitata da Roma nel mondo nello svolgersi della civiltà», che contò tra i suoi presidenti Pietro Fedele o l’ex nazionalista e più volte ministro Luigi Federzoni. L’istituto divenne luogo di ritrovo per studiosi, politici, architetti e urbanisti orientati a sviluppare e diffondere nel paese il mito della romanità, con l’obiettivo di dare copertura accademica alle volontà e alle ambizioni politiche del regime e curò, tra l’altro, una storia di Roma pubblicata in più volumi. Uno dei tanti versanti culturali dei quali il fascismo volle, in un certo senso, impossessarsi fu quello della letteratura latina, per dimostrare che la nostra letteratura e cultura affondava le sue origini in quella universale degli antichi; peccato, però, che una simile ricostruzione dimenticasse due fatti di non poco conto: diversi autori della letteratura antica non erano affatto italiani di nascita (p. es. Fedro, Seneca, Tacito) e il fatto che il latino era stato la base anche di lingue e letteratura francese, castigliana, portoghese, etc. Agli studi classici diede nuovo impulso la riforma scolastica voluta dal filosofo e ministro Giovanni Gentile (1923), che gettò le basi per quella sorta d’istruzione d’élite attribuita ancora oggi al liceo classico. Tra gli antichisti più vicini al regime, ricordiamo Ettore Pais, senatore del regno (iscritto al PNF) e direttore del trimestrale Historia, fondato da Arnaldo Mussolini (fratello di Benito), il quale scrisse una storia delle origini di Roma che gli valse, nel 1936, il premio Mussolini. Ricordiamo ancora l’archeologo Pietro Romanelli, l’etnologo Giorgio Maria Sangiorgi, che riteneva di potere conciliare il colonialismo con la tutela degli autoctoni o Mario Attilio Levi. Molti di questi studiosi si adoperarono, specie dopo la conquista dell’Etiopia, per far passare l’idea che la conquista servisse non per «… imporre, ma per estendere il concetto di popolo, unificare il mondo civile, perdonare chi si assoggetta». Il regime spese molte energie per occultare un’idea negativa o aggressiva di imperialismo, presentando la conquista dell’Africa come un’opera di civilizzazione e cristianizzazione; sotto quest’ultimo aspetto, la campagna fu sostenuta ampiamente dalle gerarchie ecclesiastiche: in un discorso del 1937 il cardinale Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, paragonò la figura storica del duce a quelle di Costatino o Augusto, salvo poi cambiare idea quando il regime assunse toni sempre più apertamente razzisti. Inoltre, sulla falsariga di quanto avvenne coi coloni romani, la conquista rappresentava un utile strumento per offrire terre e opportunità di lavoro ai cittadini italiani. Una cosa, però, è certa: la politica razziale inaugurata nel 1937, proprio contro i popoli delle colonie, fece svanire ogni ideale di civilizzazione o equiparazione dei popoli indigenti ai cittadini dell’impero fascista, presentandoli semmai come barbari da educare alla civiltà. Ulteriori discriminazioni colpirono fin dai primi anni del regime gli omosessuali, perseguiti non tanto sotto il profilo penale – in Italia, a differenza della Germania, non esisteva un reato specifico – bensì dalle autorità politiche e amministrative, specie con gli strumenti della diffida e del confino. Tuttavia, se è ostico, come pure si tentò di fare, ricondurre le discriminazioni razziali all’antichità, ancora di più lo sarebbe stato per le misure contro gli omosessuali. I romani, fortemente debitori della cultura e tradizione greca, ne avevano mutuato anche il “turpe vizio”, estirpato solo con l’avvento del cristianesimo. Il fascismo, per lo meno in questo, si limitò a interpretare diffusi sentimenti di riprova sociale e falsi miti (come quello del “maschio latino”), che lo stesso Mussolini impersonava, menando gran vanto delle numerose avventure extraconiugali. Nel caso della legislazione razziale, però, come abbiamo detto ogni eventuale tentativo di ricondurle ad altre epoche storiche si rivelò fallimentare. Distorsioni propagandistiche a parte, era difficile dimenticare che, se pure i romani erano stati fautori di un imperialismo aggressivo, sottomettendo innumerevoli popoli dell’antichità, avevano dimostrato tolleranza e rispetto per gli usi e la religione dei popoli delle province, spesso manifestando apertura alle diverse culture (come per quella greca) o garantendo diritti e opportunità ai popoli conquistati: un orientamento in netta controtendenza rispetto a quello discriminatorio delle normative razziali. Il grande castello propagandistico, infarcito di miti ispirati alla romanità, crollò definitivamente con la guerra. La disastrosa esperienza bellica renderà sempre più evidenti le falsità e le distorsioni della propaganda, mentre persino lo stesso Mussolini dovrà riconoscere che gli italiani contemporanei – depurati di fronzoli, simboli e manifestazioni esteriori – ben poco avevano a che spartire con la figura mitizzata dell’antico romano. Il duce, prendendone atto, si premurò di scaricare le colpe dell’andamento negativo del conflitto al suo popolo, dimentico di aver precipitato il paese in una vera e propria tragedia, consapevole dell’impreparazione politica e militare della nazione, nell’erronea convinzione di non combattere grazie ai rapidi trionfi dell’alleato tedesco. Mussolini ammise in alcuni sfoghi privati – riportati nei diari del genero e ministro degli Esteri Galeazzo Ciano – di non essere riuscito a creare l’italiano nuovo, prendendosela con la mentalità piccolo borghese radicata nel suo popolo. Sempre nei diari di Ciano, si legge una frase di Mussolini secondo la quale se Michelangelo per le sue opere avesse avuto a disposizione argilla e non marmo, sarebbe stato un ceramista e non uno scultore: il duce riteneva, così, di andare esente da colpe, semplicemente gli mancava la materia prima. Al di là dei deliri di un dittatore allo sbando, il tentativo di romanizzare (nel senso di inclinazione alla potenza e allo spirito guerriero) il popolo italiano si era rivelati per quello che erano: poco più di un grande circo propagandistico, privo di ogni sostanza. L’epilogo di Salò, quando Mussolini era solo l’ombra di sé stesso e aveva perso ogni controllo sulla stessa città di Roma, ne rappresenterà solo la tragica conferma; non è un caso se quando era già nell’aria la sconfitta, si parlò di Mussolini come di un “romano di cartapesta” o se, dopo il colpo di stato del 25 luglio, comparissero sui muri di alcune città italiane scritte come questa: “Voleva essere Cesare, morì Vespasiano”, con un chiaro riferimento ai bagni pubblici voluti dall’imperatore. Con ogni probabilità – scrive Emilio Gentile – “I fascisti non furono i romani della modernità, come sognava il duce, ma molti oggi pensano che i romani della Roma antica furono i fascisti dell’antichità.” Una osservazione molto acuta quella dell’autorevole storico, che indica la persistenza di un pensiero diffuso, in un certo senso figlio di una propaganda di regime che, questo bisogna ammetterlo, fu in grado di radicarlo nel comune sentire, perfino a molti anni di distanza dal suo crollo.
di Paolo Arigotti