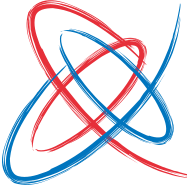Partiamo dal presupposto che poco più di dieci anni fa, nel 2011, la percentuale di energia nucleare prodotta nella Repubblica Islamica era minima, nonostante il primo programma risalisse agli anni Cinquanta, quando era ancora sul trono lo Scià Mohammad Reza Pahlavi: fu allora che Teheran siglò alcuni accordi con gli Stati Uniti – allora alleati – e con paesi europei come Francia e Germania. Nel decennio successivo gli americani fornirono agli iraniani un primo reattore e furono stanziati importanti finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo. Inoltre, l’Iran è esso stesso produttore di uranio, disponendo della importante miniera di Saghand, nei pressi della città di Yazd, situata nella zona desertica al centro del paese. La rivoluzione islamica del 1978/79 segnò un brusco arresto nella collaborazione con l’Occidente, bloccando i lavori di costruzione del primo impianto nella città di Bushehr, sulla costa meridionale iraniana, successivamente sottoposto a pesanti bombardamenti aerei durante il conflitto con l’Iraq. Solo nel 1995, grazie ad alcuni accordi con la Federazione russa, furono ripresi i lavori per la sua costruzione (assieme a tre ulteriori impianti): Mosca si impegnava a fornire manodopera e risorse, in cambio di garanzie circa l’impiego pacifico dell’energia prodotta. Nel 2000 Bill Clinton firmò nuove sanzioni contro Teheran, mentre nel 2002, una denuncia del Consiglio di resistenza iraniana sollevava forti sospetti sul fatto che l’Iran stesse mettendo a punto un programma di arricchimento dell’uranio, in particolare nei centri di Arak e Natanz, sito pilota in cui ci sono circa un migliaio di centrifughe. La notizia causò l’immediata reazione degli USA – che non hanno rapporti diplomatici con la Repubblica islamica – assieme al resto della comunità occidentale, giudicando la condotta iraniana contraria agli accordi internazionali sulla non proliferazione degli armamenti nucleari (TNP), i quali vietano ogni trasferimento o sviluppo di tecnologie nucleari con finalità non pacifiche. Gli ispettori inviati dall’Agenzia Internazionale per l’Energia atomica (AIEA), l’organismo delle Nazioni Unite che vigila sul rispetto del TNP, promuovendo l’utilizzo pacifico dell’energia dell’atomo, non riscontrarono, però, nessuna anomalia negli impianti sottoposti a verifica. Tra il 2003 e il 2004, grazie alla mediazione di Francia, Germania e Regno Unito (i cosiddetti E-3) furono siglati nuovi accordi, che in sostanza aprivano ad un utilizzo esclusivamente pacifico dell’energia nucleare, promettendo in cambio investimenti economici. Tuttavia, quando nel 2005 le elezioni presidenziali iraniane sancirono la vittoria dell’ultraradicale Mahmud Ahmadinejad, il processo negoziale si interruppe. Nonostante gli ispettori dell’AIEA non trovassero neppure in seguito nessuna prova circa l’esistenza di programmi militari, l’Occidente varò un pacchetto di sanzioni: nel 2007 fu il Consiglio di sicurezza dell’ONU a votare una serie di misure contro Teheran. All’Iran giunsero, inoltre, una serie di avvertimenti e velate minacce da parte di Washington, che preannunciava “spiacevoli conseguenze” qualora il paese si fosse dotato di armamenti nucleari; lo stesso fece Israele, da sempre in una sorta di stato guerra non dichiarata con Teheran, accusandola a più riprese di armare e finanziare il terrorismo (come il gruppo Hezbollah). Nel tentativo di smussare le tensioni, la stessa Amministrazione americana – grazie alla mediazione della Russia – si offrì di collaborare alla costruzione di un reattore nucleare, in cambio della cessazione di ogni programma di arricchimento dell’uranio, funzionale alla produzione di armi nucleari; gli americani chiedevano, inoltre, l’interruzione dei lavori per la centrale di Bushehr, completata e messa in funzione nel 2010, con l’obiettivo ufficiale di produrre energia elettrica per fini civili. L’Iran non ha accettato le sanzioni, giudicandole in contrasto con le clausole del TNP, dal quale ha minacciò di ritirarsi; allo stesso tempo, la Repubblica Islamica ha implementato il suo programma nucleare, incrementando la produzione di uranio leggermente arricchito, pure grazie al nuovo impianto di Isfahan, nell’Iran centrale, entrato in funzione nel 2009. L’anno seguente un attacco congiunto di israeliani e statunitensi (col virus Stuxnet) sembrò ostacolare i programmi di arricchimento dell’uranio in corso a Natanz. Se già a partire dal 2007, nel corso di un’audizione al Congresso statunitense dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, si parlava esplicitamente di uno scenario di guerra con l’Iran, l’arrivo alla presidenza di Barack Obama sembrò aprire nuovi spiragli. L’allora vicepresidente, Joe Biden, dichiarò in occasione della conferenza per la sicurezza di Monaco la disponibilità del suo governo ad organizzare un ciclo d’incontri con quello iraniano, anche se l’offerta cadde nel vuoto quando, pochi giorni dopo, la guida suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, accusò gli americani di voler usare il negoziato con Teheran solo per rimediare una vittoria politica in Medio Oriente, dove gli USA avevano conseguito – a suo dire – solo fallimenti. Una svolta sembrò arrivare dall’elezione alla presidenza della Repubblica Islamica del moderato Hassan Rohani, per quanto il potere decisionale resti saldamente in mano alla guida suprema e ai vertici del clero sciita; in realtà a far aprire una breccia, persino all’interno delle fazioni più radicali, contribuirono i crescenti disagi che le sanzioni occidentali stavano creando al paese. La ripresa dei colloqui con Washington, però, vide la ferma opposizione del più importante alleato degli USA nella regione, Israele, nemico giurato dell’Iran; il primo ministro dello stato ebraico, Benjamin Netanyahu, parlando nel 2015 dinanzi al Congresso (a maggioranza repubblicana) condannò qualunque ipotesi di accordo con Teheran sulla questione nucleare, paventando il rischio che ciò avrebbe spalancato le porte alla produzione della bomba atomica. Il Congresso, influenzato dalla potente lobby sionista, si schierò contro gli accordi e minacciò di non ratificare le intese eventualmente sottoscritte. Il presidente Obama, nonostante la contrarietà della maggioranza parlamentare, si mostrò risoluto nel portare avanti i negoziati, che avrebbero dovuto prevedere la riduzione del programma di arricchimento dell’uranio (sospeso nel corso dei negoziati) e l’impegno ad un utilizzo pacifico dell’energia prodotta. Il 2 aprile 2015 venne firmato a Ginevra un accordo preliminare tra USA e Iran. Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti di Russia, Cina, Regno Unito, Francia, Germania e quello dell’Unione Europea. Il testo definitivo, da siglare nel giro di pochi mesi, avrebbe dovuto contenere condizioni stringenti per gli iraniani; in cambio, l’Iran avrebbe ottenuto una riduzione delle sanzioni e l’impegno a non vararne di nuove. Sarebbe spettato agli ispettori dell’ONU, che avrebbero avuto libero accesso agli impianti del paese, verificare l’attuazione delle intese, in vista della progressiva revoca delle sanzioni. Israele a parte, gli accordi in questione – cd. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – hanno visto la ferma opposizione dell’Arabia Saudita e degli altri stati del Golfo, alleati storici di Washington e anche loro nemici giurati della Repubblica islamica. L’accordo venne lo stesso firmato il 14 luglio 2015 e ratificato pochi giorni dopo dal Consiglio di sicurezza dell’ONU. Nei successivi dieci anni l’Iran s’impegnava a ridurre di 2/3 gli impianti per l’arricchimento dell’uranio, a procedere all’azzeramento del minerale arricchito (comprese le scorie), a consentire il libero accesso degli ispettori dell’AIEA; in cambio veniva revocato il divieto di esportazione di gas, petrolio, oro e diamanti e garantita la progressiva revoca delle restanti sanzioni. Sembrava fatta, ma l’elezione del presidente repubblicano Donald Trump rimise tutto in discussione: il nuovo inquilino della Casa Bianca stracciò gli accordi del 2015, imponendo nuove e pesanti sanzioni contro Teheran. Gli iraniani, indispettiti dalle decisioni del nuovo presidente, rimisero in moto i loro programmi. Così, quando gli ispettori inviati dell’ONU visitarono l’impianto di Arak, furono avanzati sospetti sulla ripresa dei programmi militari. A novembre 2021, l’AIEA lanciava un allarme circa il significativo aumento della produzione di uranio arricchito, con un incremento delle scorte superiore al limite autorizzato. Ai primi di agosto del 2022 l’Organizzazione statale per l’energia atomica iraniana (Aeoi) ha comunicato l’attivazione di centinaia di nuove centrifughe per l’arricchimento dell’uranio, annuncio che seguiva di poche ore quello sulla capacità di Teheran di costruire la bomba atomica. Nonostante il comunicato precisasse che la costruzione dell’arma non era in agenda, arrivò ugualmente la pronta reazione di Washington, che si diceva pronta a scongiurare, anche con la forza, una simile eventualità; già a luglio il presidente Joe Biden si era espresso in questi termini. Eppure, proprio l’arrivo di Joe Biden – subentrato a Trump nel 2021 – aveva aperto uno spiraglio di pace, viste le timide aperture al dialogo del nuovo capo di stato, che aveva definito un grave errore la decisione del suo predecessore di stralciare le intese del 2015, scelta invece di attenuare, aveva semmai rafforzato la determinazione iraniana verso il nucleare. Pur tra mille tensioni, ripresero nella città di Vienna i negoziati tra USA e Iran, che portarono tra luglio e agosto scorso all’elaborazione di una nuova bozza di accordo, destinato a prendere il posto di quelli del 2015. Un ruolo decisivo nel negoziato venne dall’Unione Europea, che fungeva da mediatore. Gli accordi in questione, però, non sono stati ancora sottoscritti. A parte il “tira e molla” proseguito per tutto il mese di agosto, e in buona parte ancora in corso, hanno avuto il loro peso una serie di equilibri internazionali, non ultimi quelli legati al ruolo della Russia e dei principali attori mediorientali. L’Iran ha subordinato la propria firma al rispetto di una serie di condizioni, tra le quali il rispetto dei suoi interessi economici e il fatto che la nuova intesa non possa essere messa in discussione da un cambio della guardia alla Casa Bianca. Ai primi di settembre, Teheran ha confermato la volontà di negoziare, a patto di non ricevere richieste “eccessive” da parte degli americani e di ottenere un impegno per la revoca delle sanzioni; inoltre, l’Iran vorrebbe ottenere la rimozione del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) – un organo militare dello stato – dal novero delle organizzazioni terroriste. Come nel 2015, la prospettiva dell’accordo sul nucleare ha incontrato la netta contrarietà di Israele, che per bocca del primo ministro Yair Lapid ha parlato di un patto che non solo regalerebbero a Teheran ingenti risorse finanziarie (si parla di 100 miliardi di dollari all’anno), ma che potrebbe minare la stabilità della regione e fomentare il terrorismo, dichiarando sin d’ora che il suo paese non si sentirà in nessun modo vincolato dagli eventuali accordi. In questo senso, Tel Aviv può contare sull’appoggio degli Emirati Arabi – coi quali sono state da poco allacciate relazioni diplomatiche – che già in occasione del viaggio di fine 2021 dell’allora premier israeliano Naftali Bennet a Dubai, avevano concordato sulla necessità di contenere le mire egemoniche della Repubblica Islamica; lo stesso capo del Mossad, David Barnea, ha parlato di possibili azioni ostili contro l’Iran. Non va dimenticato che i due stati hanno parecchi conti in sospeso, come ad esempio in Siria, e lo stesso dicasi per la storica rivalità tra Ryad e Teheran, palesata dalla lunga guerra in Yemen, che ovviamente fa storcere il naso di fronte alla prospettiva che l’Iran possa dotarsi di armamenti atomici. Inoltre, Israele vuole conservare il primato di unica potenza nucleare dell’area, e possiamo essere certi che la potente lobby sionista di Washington eserciterà tutte le pressioni del caso. A remare contro l’eventuale intesa è anche il clima di sostanziale sfiducia da parte delle nazioni occidentali riguardo le reali intenzioni pacifiche dell’Iran, come di riflesso la diffidenza di Teheran nei confronti di americani e AIEA, “dirottata e sfruttata” da Israele. L’interesse all’accordo da parte europea è stato rafforzato dal conflitto ucraino e della volontà di questi paesi di ridurre, se non azzerare, la dipendenza dagli idrocarburi russi. Chiaramente l’eventuale revoca dell’embargo (imposto dagli USA) contro chiunque commerci con gli iraniani, aprirebbe una nuova e importantissima fonte di approvvigionamento, ma non è pensabile che una simile decisione venga presa senza il placet degli americani. E poi, non vanno trascurate le crescenti tensioni tra Occidente e Russia, che non solo è un alleato di ferro di Teheran, sostenendone le ragioni al tavolo dei negoziati, ma soprattutto ha un interesse specularmente opposto al raggiungimento di un’intesa con gli occidentali su nucleare ed embargo, perché lo priverebbe di un importante alleato, oltre che liberare, almeno in parte, gli europei dal “ricatto energetico” di Mosca; detto in altri termini, chi glielo farebbe fare a Putin di perdere un importante alleato, che per giunta potrebbe, almeno parzialmente togliere le “castagne dal fuoco” ai paesi che lo stanno colpendo con le sanzioni? In tal senso, non è certo un caso se lo scoppio del conflitto in Ucraina abbia “rallentato” i negoziati di Vienna. Nelle more degli accordi, ammesso che mai verranno sottoscritti, il nuovo ordine mondiale avanza (magari ne parleremo in un altro episodio) e sembra che l’Iran stia già decidendo da che parte stare. A conferma delle voci che già circolavano, a fine agosto l’Iran ha chiesto di aderire ai BRICS; inoltre, nelle scorse ore si è tenuto a Samarcanda – nell’ambito del meeting dei paesi della Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) – un incontro tra il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il collega russo Vladimir Putin, nel corso del quale quest’ultimo ha parlato di posizioni molto vicine sulle questioni internazionali, preannunciando nuovi accordi di cooperazione. Appare di tutta evidenza come questi fatti avranno il loro peso sui negoziati sul nucleare oltre che, più in generale, su molti degli attuali (e mutevoli) equilibri internazionali.
di Paolo Arigotti