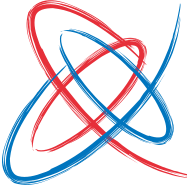Zygmunt Bauman ha origini polacche ed ebraiche.
Nato nel 1928 e rifugiatosi con la sua famiglia nella Polonia orientale occupata dai sovietici, prese parte alla resistenza nella zona del paese occupata dall’armata rossa. Laureatosi in sociologia all’Università di Varsavia, fu osteggiato dal regime comunista in quanto ebreo ed intellettuale, fino al punto di abbandonare la sua terra natale.
Rifugiatosi in Israele, insegnò presso l’Università di Tel Aviv, per poi lasciare lo stato ebraico in disaccordo con le scelte governative dopo la guerra dei sei giorni; si trasferì, quindi, in Inghilterra, avendo già collaborato con la London School of Economics, dove ebbe una cattedra nell’Ateneo di Leeds.
Nei suoi studi ha affrontato varie tematiche, tra cui i meccanismi di inclusione (ed esclusione) sociale, la precarizzazione e perdita di sicurezza sociale, la questione della globalizzazione.
In Modernità e Olocausto (1989) l’autore esamina a fondo il fenomeno della shoah, prendendo nettamente le distanze dai filoni interpretativi che la collocano fuori dei processi di civilizzazione moderna.
Nel ricercare le origini e spiegazioni di questa immensa tragedia, a cominciare dal più importante degli interrogativi (“Come fu possibile?”), varie sono state le soluzioni proposte.
Se le ricostruzioni della sociologia tradizionale sostengono che l’avvento dello stato moderno, assieme ai processi di civilizzazione che lo accompagnano, comportino migliori e più fattivi rapporti sociali, la shoah andrebbe vista come una deviazione ed un arretramento.
In effetti, l’idea di una schiera di fanatici razzisti, affetti magari da serie patologie mentali, potrebbe apparire una spiegazione convincente; un regime criminale e ben organizzato, avversario delle moderne conquiste della civiltà e della democrazia, ebbe facilmente ragione di una schiera di vittime innocenti ed indifese.
E’ questa l’immagine sinistra di uno stato che pensa ed agisce come un “giardiniere”, curando le piante “buone” ed eliminando quelle infestanti.
In pratica, asserendo che lo stato moderno ha ragione degli istinti umani più barbari e primordiali (a cominciare dalla cieca violenza), dominandoli col primato della legge e dell’ordine, unica spiegazione plausibile della shoah è un fallimento (magari temporaneo) di un sistema imperfetto, ma perfettibile; il sistema moderno e civile – munito dei giusti anticorpi – avrebbe la capacità di prevenire simili tragedie, impedendone che si ripetano.
Inoltre, sostenere che l’olocausto sia una deviazione rispetto ai processi di modernizzazione propri della civiltà contemporanea, fa sì che questi ultimi non possano o debbano essere messi in discussione; in altre parole, la civilizzazione funzionerebbe egregiamente e la shoah è potuta accadere solo in quanto ci si allontanò da essa.
Portata agli estremi, una simile interpretazione vedrebbe la shoah come un “capitolo chiuso”, definito con la sconfitta del nazismo ed il ritorno alla (ed il trionfo della) civiltà contemporanea; non si tratterebbe di un evento col quale rapportarsi, bensì di un fatto storico, appartenente ad un passato ormai sepolto (un “quadro appeso alla parete”, ricorrendo ad un’espressione dello stesso autore).
Bauman ritiene – al contrario – che l’olocausto si inquadri perfettamente e sotto molteplici aspetti nel contesto della modernità, ben lungi dal costituirne una sorta di stasi temporanea (una “buia parentesi” nel cammino verso la civiltà).
Le tesi che vorrebbero imputare il genocidio ebraico alla personalità demoniaca di Hitler (e dei più fanatici gerarchi nazisti) o ad una sorta di delirante patologia insita nell’antisemitismo tedesco (peraltro non unico in Europa, né l’esempio più fanatico), avrebbero una sorta di effetto salvifico ed assolutorio, cancellando ogni ulteriore e diversa responsabilità.
Va pure aggiunto – l’autore dedica, a tal fine, una breve ma significativa panoramica alla storia dell’antisemitismo in Europa, col passaggio da quello di matrice religiosa al biologico razziale avvenuto nella seconda metà del XIX secolo – che l’avversione contro l’ebreo in quanto tale non trovò in Germania terreno più fertile che altrove.
Il culmine si sarebbe raggiunto quando si passò dalla semplice inimicizia competitiva (leggi antagonismi sociali) e avversione verso il “diverso”, in qualche modo connaturali a qualunque assetto sociale, alle argomentazioni pseudo scientifiche, fino a giungere all’ultimo stadio: un razzismo sostenuto da ragioni di tipo biologico razziale.
Partendo da questi presupposti ed ammantandoli di legalità, mediante l’approvazione di una serie di provvedimenti normativi (a cominciare dalle famigerate leggi di Norimberga del 1935), lo Stato divenne arbitro e giudice esclusivo di chi “meritasse” di appartenere alla comunità degli “eletti” (i cittadini di stirpe ariana e convinti nazionalsocialisti), rispetto a coloro che ne erano esclusi per varie ragioni: gli asociali (es. oppositori politici, omosessuali, fannulloni), i malati (disabili), gli appartenenti alle razze “inferiori” (es. sinti, rom ed ebrei).
E’ appena il caso di notare che in forza di tali provvedimenti, subentra la logica del potere costituito e dell’autorità che ne cura l’attuazione, impartendo gli ordini esecutivi a schiere di subordinati che lungi dall’essere bestie assetate di sangue, al contrario sono spesso uomini comuni con una vita assolutamente normale.
Il ricorso a procedure autorizzate (dall’entità superiore), standardizzate (riguardo le modalità pratiche ed attuative) e spersonalizzate (nel senso che vedremo) fece il resto.
Questo smentisce nettamente la tesi secondo cui ordine e disciplina (paradigma dello stato moderno) siano una barriera contro l’emersione di fatti brutali e violenti: durante il Terzo Reich essi avvennero piuttosto nell’ambito della “legalità”.
Il principio rigidamente gerarchico, del resto, ebbe un ruolo non secondario per lo scaricamento delle responsabilità (quantomeno morali) degli attori del genocidio, messi nelle condizioni – quali meri esecutori di ordini giunti dall’alto – di vedere sé stessi come semplici anelli di una lunga della catena, e non complici di uno sterminio.
A questo proposito, un aspetto che preme sottolineare è che non si deve vedere nello sterminio l’obiettivo, quanto piuttosto il mezzo per raggiungere lo scopo finale: la creazione della perfetta comunità popolare, ottenuta attraverso l’eliminazione degli elementi indesiderati.
Questi ultimi dovevano essere estirpati dalla comunità popolare, quasi si trattasse di erbe infestanti (torna l’immagine dello stato “giardiniere”) o malattie da debellare (la lotta contro bacilli e mali contagiosi fu ampiamente sfruttata dalla propaganda antisemita).
Messa in soffitta la visione premoderna dell’ebreo peccatore (deicida e rinnegatore del Cristo), che poteva e doveva essere redento (anzitutto con la conversione), il giudeo appartenente alla razza “imperfetta” può essere solo eliminato dalla comunità: quando l’emigrazione non sarà più sufficiente per rendere il territorio controllato dai nazisti judenrein, non rimarrà che la “soluzione finale”.
Il pensiero di Bauman si inquadra perfettamente nella tesi della storiografia funzionalista, secondo la quale il progetto genocida non fu una scelta premeditata e programmata fin dall’inizio, bensì il frutto di una lenta evoluzione e di una serie di fattori, non ultimo lo scatenamento del conflitto e l’avvio della guerra di annientamento nell’URSS, dopo l’invasione delle armate hitleriane.
Chiaramente la sua pratica realizzazione richiedeva la messa in atto di una serie di misure (modernissime): una martellante propaganda, una solerte burocrazia ed apparato organizzativo, l’anestetizzazione delle coscienze, la spersonalizzazione e collaborazione delle vittime.
Ultimo ed inquietante interrogativo: che fine fecero etica e morale?
E’ storicamente provato che molti tedeschi (compresi coloro che votarono per Hitler) non erano convinti razzisti; in tanti, è vero, approvarono la legislazione anti ebraica, ma si registrarono (perfino nei rapporti di polizia) diffusi sentimenti di riprovazione verso le discriminazioni antisemite (a cominciare dalla notte dei cristalli) e non furono pochi a manifestare solidarietà e fornire aiuti concreti ai perseguitati (talvolta a costo della vita).
Per cercare di estirpare questi sentimenti pietosi e solidali, i nazisti fecero leva tanto sulle radicate credenze popolari e tradizioni storiche che avvolgevano la figura dell’ebreo in quanto tale (l’ebreo avaro e strozzino, l’infido al servizio del potente di turno per opprimere le masse, il corruttore), quanto sulle più moderne dottrine razziste, che dipingevano i giudei un’etnia a parte (in senso biologico), sempre pronta ad ordire complotti per corrompere ed inquinare la razza “eletta”.
Così anche la parità dei diritti e l’eguaglianza dinnanzi alla legge (questa si conquista del moderno stato di diritto) era presentata dal nazismo come un attentato contro le leggi della natura, che volevano – questo si asseriva – la diseguaglianza delle razze umane.
Per fomentare ulteriormente gli animi, si imputava all’ebreo in quanto tale ogni male della modernità (a cominciare dal presunto dominio su mercato e denaro), con conseguente smarrimento dei rassicuranti valori tradizionali; quasi un paradosso: ci si richiamava alle tradizioni per giustificare, col ricorso ai mezzi più avanzati, un autentico genocidio.
La solerte burocrazia fu chiamata ad attuare il fine (per quanto moralmente riprovevole) indicato dall’autorità suprema (il Fuhrer), ricercando le soluzioni razionalmente ed economicamente più idonee alla sua realizzazione (nella logica dell’analisi costi/benefici e del problem solving); giova sottolineare che, in difetto di questo apparato, ispirato a standard di razionalità ed efficienza propri delle più avanzate elaborazioni scientifiche, assai difficilmente si sarebbe realizzata, in tempi così brevi, l’uccisione di milioni di esseri umani.
Per meglio comprenderne l’importanza, basti pensare all’azione di una folla inferocita o di un movimento rivoluzionario, similmente a quanto accaduto in occasione delle tante stragi che la storia ci riporta; nessuno di tali fatti ha mai prodotto un numero così elevato di vittime in poco tempo.
La stessa notte dei cristalli rappresentò, in questo senso, uno dei tanti pogrom antisemiti, ma mai avrebbe potuto definire la questione ebraica.
Il genocidio su larga scala e scientificamente pianificato necessitava del ricorso a ben altri mezzi.
Le camere a gas furono scelte per gli eccidi di massa perché garantivano la migliore “resa” in termini di efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti), efficacia (raggiungimento degli obiettivi prefissati) e speditezza (rapidità di esecuzione).
Ulteriore vantaggio, la gassificazione riduceva al minimo (fino quasi ad annullarlo) il rapporto diretto tra carnefici e vittime, evitando così il ripetersi di traumi psicologici riscontrati tra i membri dei plotoni di esecuzione impiegati, in una prima fase, per l’uccisione degli ebrei.
E’ pacifico, difatti, che la distanza (in senso fisico) tra autore e vittima di un’azione cruenta limiti o annulli quasi del tutto ogni freno inibitorio dettato dalla coscienza individuale, cancellando la naturale ritrosia a provocare sofferenza nel prossimo, specialmente quando si tratti di sopprimere vite innocenti (donne o bambini).
Proprio una simile analisi, cinicamente e freddamente razionale, fu condotta da coloro che pianificarono il genocidio, scongiurando il rischio che pietà, sensi di colpa o rimorsi potessero rallentare o compromettere lo sterminio.
In fondo, non è una situazione molto diversa da quella del soldato moderno che può causare migliaia di vittima ricorrendo ad ordigni o armamenti messi in funzione magari premendo un pulsante a distanza (torna il concetto della lontananza fisica tra vittima e carnefice): il militare delle SS liberava dall’alto, mediante una finestrella posta sul soffitto della camera a gas, i granuli del micidiale zyklon B, senza avere nessun contatto con le sue vittime.
In ambedue i casi ci si limita ad eseguire una mansione di tipo tecnico e routinario, allontanando dagli occhi (e dalla coscienza) gli effetti pratici della propria azione.
Si potrebbe parlare di “anestetizzare” la coscienza umana ricorrendo alla tecnica moderna: eliminando il contatto fisico tra omicida e vittima, si evita ogni contraccolpo psicologico.
Alla luce di quanto precede, si può a questo punto comprendere quanto assai meno compromettenti per la coscienza degli autori fossero ruoli o compiti esclusivamente burocratici (pensiamo agli impiegati di un ufficio amministrativo) o operativi (i ferrovieri che guidavano i treni diretti ad Auschwitz); dopo tutto anche loro si limitavano a svolgere il proprio “lavoro”, un po’ come l’operaio di una fabbrica che produce armi di distruzioni di massa.
In altri termini – ecco un altro tratto del moderno apparato burocratico – la responsabilità morale viene sostituita da quella tecnica; non è un caso che l’ufficio delle SS incaricato della gestione dell’olocausto fosse chiamato economico amministrativo.
Altro elemento tipico della modernità, riscontrato da Feingold, è lo stesso funzionamento dei lager come una sorta di industria dell’orrore, con l’essere umano (vittima) ridotto a materia prima (peggio, una semplice cosa) e la sua morte come il prodotto finale (simboleggiato dal fumo acre delle ciminiere).
Come si accennava, un fattore del quale occorre tener conto fu il progressivo ma incessante processo di “spersonalizzazione” delle vittime.
Il ricordato varo in Germania (e non solo in questo paese) di misure sempre più discriminatorie ed isolazioniste nei confronti degli ebrei fecero di questi ultimi un’etnia a parte, sempre più aliena dalla quotidianità.
Si cominciò con l’allontanamento dai posti di lavoro e dall’ambiente sociale, poi si passò all’obbligo di portare il contrassegno (stella gialla) come tratto distintivo rispetto agli “ariani”, infine si attuò il “trasferimento” verso est; queste misure, dilazionate nel tempo, provocarono nella gente comune – al di là di indiscutibili e comprovati episodi di solidarietà verso i perseguitati – una sorta di progressiva assuefazione, degenerata poi nell’indifferenza.
Questo sentimento di apatia si poté riscontrare specialmente quando le misure discriminatorie – ancora una volta troviamo il concetto della “distanza” – colpivano persone sconosciute e con le quali non si aveva nessun tipo di rapporto.
Quando le preoccupazioni della guerra – i propri cari impegnati al fronte, i bombardamenti, la penuria di derrate alimentari, la paura della morte – ebbero il sopravvento, gli ebrei non rappresentavano neanche più un problema per la maggior parte della popolazione tedesca (e non solo).
La stessa opzione del trasferimento verso est degli ebrei (tedeschi prima, europei delle nazioni occupate o collaborazioniste poi) non fu estranea a meccanismi di cinica e scientifica premeditazione.
Questa misura, tacciata come un mero spostamento in senso fisico e geografico, contribuiva a creare quel distacco, che impedisse ogni forma di protesta contro la politica genocida, facendo tesoro dell’esperienza maturata con il cosiddetto progetto “eutanasia” (uccisione dei disabili), ufficialmente sospeso dal regime nazista nel 1941 proprio per effetto delle proteste dei cittadini comuni, a cominciare da coloro che vivevano in prossimità delle strutture “sanitarie” dove venivano perpetrati i delitti.
Non a caso, i campi di sterminio sarebbero stati collocati nei territori della Polonia occupata, lontani dagli occhi (e dalle coscienze) della gente comune.
Per quanto suoni incredibile, un significativo contributo all’efficienza della moderna industria della morte fu dato dalle stesse vittime.
Erano i consigli ebraici (Judenrate) che amministravano i ghetti dove furono confinati gli ebrei prima di essere avviati ai lager; gli stessi organismi, scelti dai nazisti tra gli esponenti più anziani ed autorevoli delle comunità, fungevano da cinghia di trasmissione delle volontà dei persecutori e svolgevano una serie di compiti preparatori per l’eccidio (censimento della popolazione e dei beni, mantenimento dell’ordine e polizia del ghetto, e così via).
I nazisti fecero ampi sforzi per ottenere la collaborazione delle vittime – indotte dall’illusione di salvare sé stessi o il maggior numero di vite possibile dalla furia omicida- consapevoli che avrebbe rappresentato (come effettivamente rappresentò) un fattore di efficientamento dell’ingranaggio genocida.
Pure in questo senso, la macchina messa in moto dai nazisti è una dimostrazione eloquente del potere moderno di promuovere azioni funzionali ai propri fini, facendo leva sulla razionalità umana, per quanto in stridente contrasto con gli interessi vitali degli attori coinvolti.
Di fatto si misero le vittime di fronte ad una scelta (razionale) tanto apparente quanto illusoria: quella del male minore.
Si innestano nello stesso filone la previsione di scriminanti (es. per gli ebrei che avevano combattuto per la Germania durante la grande guerra), l’avvio all’est tacciato per mero trasferimento (e non deportazione), il ruolo dei consigli ebraici all’interno dei ghetti, le distinzioni tra ebrei autoctoni e stranieri, per finire con la terrificante beffa delle camere a gas presentate come “sale da bagno”.
In tutti questi casi, una cinica e razionale “presa in giro” fu messa in atto quale strumento ottimale per il raggiungimento dello scopo.
La collaborazione con gli aguzzini, vista come unica chance di salvezza per ottenere migliori condizioni di vita, garantiva ai carnefici un indubbio vantaggio: si tenevano buone le vittime, risparmiando così risorse ed energie per lo sforzo bellico, invece che disperderle nella sorveglianza e controllo di milioni condannati a morte.
Così pure il trasferimento graduale, prima dal paese d’origine ai ghetti e poi (se non direttamente verso) i lager rispondeva a canoni di efficienza, non risultando conveniente o gestibile un’unica operazione in grande scala, che avrebbe richiesto la disponibilità di ben altri mezzi e risorse.
Tutti gli elementi di modernità che contraddistinguono l’olocausto non possono non sollevare dubbi ed inquietudini nei contemporanei.
La manipolazione di una serie di fattori politici e sociali lo contraddistinguono, unitamente ad indiscutibili elementi di fragilità insiti nella cosiddetta società civilizzata.
Questo suscita il più inquietante degli interrogativi: il mondo potrebbe ancora essere precipitato in tragedie analoghe?
La persuasione che nelle condizioni attuali questo “non potrebbe essere possibile” non può rappresentare un fattore di rassicurazione, come non lo fu settant’anni fa.
Lo stessa dicasi per i filoni interpretativi cui si accennava all’inizio, che consegnando la shoah ad un passato remoto ed irripetibile, negando ogni rapporto con la civiltà moderna.
Per questa ragione non è sufficiente serbare (come doveroso) la memoria di quel che fu – a fronte del dilagare di tesi negazioniste e della progressiva scomparsa di coloro che ne furono testimoni diretti – ma pure comprendere a fondo la lezione proveniente dall’olocausto.
Il fatto stesso che ai giorni nostri quell’embrione di governo mondiale rappresentato dall’ONU celi la sua inerzia, a fronte di terribili stragi e nuovi genocidi, con la politica della “non ingerenza negli affari interni degli stati membri”, suscita non poche perplessità.
Il fatto che perfino i nazisti avvertirono la necessità, di fronte al timore dei malesseri e sentimenti di riprovazione della gente comune (nonostante la spersonalizzazione delle vittime), di celare in luoghi remoti e segreti il processo di sterminio – memori dell’esperienza del progetto eutanasia – la dice lunga su quanto reazioni e proteste possano impedire o gravemente ostacolare la consumazione di delitti tanto efferati.
Un cenno doveroso meritano tutti coloro che si opposero (anche a costo della vita) al progetto criminale: dai cittadini comuni che aiutarono e nascosero gli ebrei, agli scienziati che lasciarono il paese rifiutando ogni complicità con Hitler, fino ad arrivare ai membri della resistenza tedesca (nonostante la feroce azione repressiva della dittatura) ed ai membri dei consigli ebraici che – pur di non scendere a patti con gli aguzzini – preferirono la morte.
Tutto questo dimostra come il più criminale dei sistemi politici non può mai mettere a tacere la coscienza delle persone, una delle poche barriere contro il ripetersi di simili orrori e come un’autentica forma di democrazia politica (possibilmente non di “importazione”) possa essere un freno ai rigurgiti violenti e genocidi (ne è riprova il fatto che la prima preoccupazione di Hitler, dopo la nomina al cancellierato, fu di spazzare via libertà democratiche e organizzazioni antagoniste).
Questo dev’essere un importante spunto di riflessione per i contemporanei; se si può umanamente comprendere quanto le pressioni (e le paure) suscitate da un apparato feroce e repressivo come quello nazista potessero indurre al silenzio, non si può negare che in tanti (non solo perché “abbindolati” dalla propaganda di Goebbels) chiusero tutti e due gli occhi per non vedere, lasciando al loro destino qualcuno che era “distante” da loro.
Se perfino tra gli ebrei si fece il ragionamento di sacrificare pochi per salvare tanti (a cominciare dalla propria vita), si può affermare che il nazismo – sfruttando sapientemente le conquiste della modernità – seppe creare le condizioni di efficienza e razionalità che permisero l’olocausto.
Inquietante, in tal senso, l’avvertimento dell’autore: non sono mutate le condizioni che permisero il genocidio.
Il moderno stato nazionale, che si arroga il diritto di uccidere e/o perseguitare interi popoli; le tecnologie più avanzate, che possono produrre un numero forse maggiore di vittime rispetto a quelle di allora; l’indifferenza ed apatia generale per un qualcosa che “non ci riguarda” o che avviene “lontano da noi”; l’atteggiamento lassista e perfino egoista di gran parte del mondo civilizzato (se o fin quando certe tragedie non abbiano dei riflessi diretti o colpiscano sfere di interesse economico o strategico).
Sicuramente l’olocausto poté essere realizzato solo con il concorso di circostanze e fattori assieme rari e peculiari: uno stato governato da un regime assoluto e criminale, lo stato di guerra, l’apatia generalizzata, ma non ci si deve nascondere che simili condizioni non si collocano fuori, bensì dentro la modernità.
Fattori per noi rassicuranti come cultura, istruzione, scienza, informazione non impedirono la shoah, anzi non mancarono episodi di collaborazione attiva del mondo accademico col regime al potere, magari solleticati (al pari di molti industriali o finanzieri in campo economico) dai vantaggi offerti dal nazismo.
La stessa immagine dell’uomo civilizzato, che rifugge violenza e brutalità, non può essere di conforto se – come scriveva Primo Levi – nei lager non circolavano “mostri” ma persone assolutamente ordinarie, magari con un elevato livello di scolarizzazione (Frank era un avvocato, Himmler un laureato in agraria….).
Verrebbe quasi da giungere alla conclusione che la crudeltà non è un fattore umano, ma piuttosto sociale: è la società moderna che crea il “mostro”, non il contrario…
Gli stessi concetti di “etica e morale” come argine contro degenerazioni ed orrori hanno una valenza molto più limitata di quanto non si possa pensare: a parte l’ovvia affermazione che ogni società crea la sua morale e che la stessa è molto soggettiva ed estremamente mutevole nel tempo, occorre considerare che la norma morale nasce storicamente a presidio di determinate esigenze, al variare delle quali il precetto cade in desuetudine.
In altre parole, se la società non crea essa stessa la morale – la quale spesso affonda le sue radici in esigenze ed istanze sociali che precedono la nascita della società stessa – essa dispone tuttavia di efficacissimi strumenti per manipolarla ai suoi fini.
Probabilmente una delle novità più inquietanti consegnateci dalla shoah è data non tanto dalla probabilità che simili orrori possano essere fatti a noi, ma piuttosto dall’idea che ogni individuo – fagocitato dai meccanismi perversi della modernità e plagiato dalla logica del “branco” (la collettività) – possa commetterli a danno di altri.
Per concludere, si può affermare che solo la combinazione di memoria ed esatta comprensione della shoah – evitando il ricorso a costruzioni semplicistiche e pretesamene assolutorie – potranno davvero evitare il ripetersi di simili tragedie.
Non va dimenticato che nel 1941 in tanti rifiutavano di immaginare quanto stava avvenendo (l’inimmaginabile…).
di Paolo Arigotti