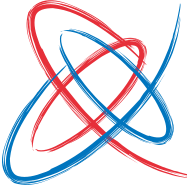In precedente articolo abbiamo analizzato il processo storico e le vicende politiche che portarono alla proclamazione dello stato di Israele il 14 maggio 1948 ed accennato all’immediata reazione del mondo arabo, che il giorno seguente (15 maggio) sferrava l’attacco, destinato a sfociare nel primo dei numerosi conflitti arabo israeliani. Va detto che gli inglesi, affidando la Palestina ai sionisti, avevano lasciato parecchie armi agli arabi; probabilmente gli ex mandatari non erano i soli a pensare che lo stato ebraico non avrebbe resistito a lungo in un mondo decisamente ostile. Come vedremo, parliamo di una situazione conflittuale evolutasi nel tempo, che ancora oggi è ben lungi dall’essersi risolta e/o aver riportato la pace nella martoriata regione.
Lo stato ebraico è stato percepito fin da subito come una sorta di avamposto dell’occidente in terra araba, pure per via dei rapporti preferenziali con gli americani; in realtà si tratta di un’entità politica del tutto autonoma, sia pur vista dai vicini – a causa della sua nascita e dei suoi caratteri politici e religiosi – come una sorta di corpo estraneo. La prima guerra durò fino al gennaio del 1949 e si risolse in una sonora sconfitta per gli stati arabi, dando avvio al primo esodo di massa dei palestinesi, in fuga dalla paura e dalla guerra, sempre nella speranza di farvi ritorno dopo la sconfitta israeliana. Il conflitto segnò la prima espansione territoriale dello stato ebraico (26 per cento in più di quanto assegnato dall’ONU), che acquisì la parte occidentale di Gerusalemme (in teoria in quota araba), unitamente ad altri territori che secondo la famosa risoluzione del 1947 sarebbero dovuti pertenere al mai nato stato di Palestina (per effetto delle varie guerre Israele finirà per possederne ben l’81 per cento). A sua volta la Transgiordania occupava una parte di quei territori, mutando con l’occasione il proprio nome in Giordania.
Molti degli arabi che vivevano nelle zone occupate dagli israeliani (circa un milione di persone) fuggirono verso il vicino regno hashemita, incrementando ulteriormente la quota di popolazione di origine palestinese dello stato. Come si spiega che uno stato neonato, circondato da vicini ostili ed unica democrazia dell’area mediorientale, riuscisse ad avere ragione di tutti i suoi avversari? Le motivazioni sono molteplici.
Un rilievo indiscutibile ebbero le rimesse delle comunità ebraiche mondiali e gli aiuti statunitensi, così come sul versante economico un modello di sviluppo fondato sull’industria e sull’agricoltura di tipo cooperativistico; a tutto questo va sicuramente aggiunto un forte spirito patriottico, promosso da una classe politica che seppe farvi efficacemente leva. Ben Gurion, leader laburista e sionista, sarebbe rimasto saldamente alla guida dello stato, nel ruolo di premier, fino al 1963, garantendo una forte stabilità politica. Ulteriore fattore di sviluppo furono le immigrazioni di circa 700mila persone tra il 1948 e 1951 (solo nel 1949 la popolazione aumentava del 50 per cento) che portarono nello stato ebraico una popolazione di elevato livello culturale e professionale. Questo non deve far pensare che gli inizi fossero dei più semplici: molti dei nuovi cittadini provenivano da paesi assai diversi (Europa, Sudamerica) ed un importante afflusso arrivava dallo Yemen (e da altri paesi arabi), dove gli ebrei locali emigrarono in massa, per sfuggire alle persecuzioni iniziate dopo la nascita del nuovo stato. Nacquero così le prime discriminazioni interne, per esempio tra gli europei e quelli di diversa provenienza, giudicati rozzi ed incolti dalla élite al potere (prevalentemente di origine europea).
L’aumento vertiginoso della popolazione creò i primi problemi di approvvigionamento alimentare ed energetico, per cui furono introdotte restrizioni e razionamento alimentare. Il governo di Ben Gurion, nonostante le proteste interne, si trovò costretto a fare ricorso ai risarcimenti tedeschi per l’olocausto; non mancarono, a tale riguardo, le proteste, specie se teniamo conto che negli anni ’50 un quarto degli abitanti erano reduci dei lager. Per sopperire alla penuria di alloggi, molti degli immigrati (specie i non europei) furono destinati alle fattorie collettive, dove per la verità non tutti andarono volontariamente. La presa d’atto delle difficoltà indusse il governo, a partire dal 1951, a limitare i flussi migratori. Nel frattempo, il paese cresceva (nuove industrie e fattorie collettive), registrando un incremento annuo di PIL del 10 per cento. Una nuova crisi militare coinvolse il Medio Oriente nel 1956 (cosiddetta crisi di Suez). Il nuovo leader egiziano Gamal Abdel Nasser, che nel 1952 aveva preso il potere rovesciando la monarchia filoccidentale ed instaurando un regime repubblicano di ispirazione socialista (ed avvicinandosi all’URSS), mirava a conquistare la leadership del mondo arabo, anche agitando il vessillo della lotta contro Israele.
Quando nel 1956 gli USA, per contrastare la nuova linea politica di Nasser, interruppero i finanziamenti per la costruzione della diga di Assuan, funzionale all’elettrificazione dell’Egitto, il presidente reagì nazionalizzando la compagnia che gestiva lo strategico canale di Suez. Israele, alleata con Francia e Regno Unito che avevano nell’area interessi strategici ed economici, attaccarono l’Egitto: lo stato ebraico occupò il Sinai, francesi e britannici fecero lo stesso con il canale. Ma l’epoca del colonialismo era tramontata e la reazione delle due superpotenze, USA ed URSS (che minacciò il ricorso all’arma nucleare) contro l’incursione fu durissima e costrinse israeliani ed europei ad abbandonare la partita. Nasser ad ogni modo divenne un punto di riferimento per il nazionalismo arabo e negli anni successivi diverse monarchie furono abbattute e sostituite da regimi ispirati al suo modello (Siria, Iraq, Libia), per quanto il sogno dell’unità araba naufragasse ben presto.
Il Medio Oriente si trasformò rapidamente in uno dei teatri di scontro indiretto tra sovietici ed americani. I primi appoggiavano gli arabi (che si rifiutavano di riconoscere Israele), i secondi lo stato ebraico, con una tensione fatta di scontri continui. Qualcuno ha ipotizzato che il famoso processo Eichmann del 1961 (conclusosi con la condanna a morte dell’ex nazista rapito e trascinato a Gerusalemme dall’intelligence di Tel Aviv) sarebbe stata una mossa politica del governo per guadagnarsi una rivincita dopo l’umiliazione egiziana e gridare al mondo che lo stato ebraico (e gli ebrei in generale) non erano agnelli che si facevano macellare impunemente: forse lo stesso Ben Gurion sperava così di impressionare favorevolmente la nutrita comunità ebraica internazionale che non aveva scelto Israele per vivere, oltre che educare i giovani a quello che era accaduto. Nel giro di due anni il fondatore lascerà la politica attiva, per ritirarsi in una fattoria collettiva. Levi Eshkol prese il suo posto. Nel 1966 si arrivò ad un nuovo conflitto (il secondo arabo israeliano, detto guerra dei sei giorni per via della brevissima durata).
Ancora una volta fu l’iniziativa di Nasser a scatenare l’offensiva israeliana, quando in accordo con la Giordania decise la chiusura del golfo di Aqaba, vitale per gli approvvigionamenti di Tel Aviv. La propaganda ebraica giustificò l’attacco come una strategia preventiva contro presunti piani arabi di invasione e sterminio, probabilmente enfatizzati per garantirsi un forte consenso interno. Il 5 giugno furono attaccati contemporaneamente tutti gli stati vicini (Egitto, Giordania, Siria), con una nuova ed umiliante disfatta per gli arabi.
Trentamila morti a fronte di poche centinaia di caduti per lo stato ebraico, che conquistò nuovi territori: le alture del Golan strappate ai siriani, il Sinai preso all’Egitto, i territori ad occidente del fiume Giordano e Gerusalemme est (la città vecchia) ai giordani: la città così riunificata fu proclamata nuova capitale israeliana, anche se a tutt’oggi gran parte del mondo non l’abbia riconosciuta come tale ed i governi stranieri conservino Tel Aviv come sede delle proprie rappresentanze diplomatiche. Il conflitto causò un nuovo flusso di profughi palestinesi verso la Giordania (circa 400 mila persone), che andarono ad ingrossare i già affollati campi profughi presenti nel paese. Circa un milione di arabi in più si ritrovava così all’interno dello stato di Israele (150mila i nuovi profughi), che aumentava considerevolmente la propria superficie geografica. Iniziò in questo momento la colonizzazione (e militarizzazione) massiccia dei territori strappati agli arabi (la cosiddetta Cisgiordania o West Bank), che diventerà uno dei motivi di maggiore attrito. Tra i fautori di una politica di risolutezza col mondo arabo (arrivando perfino a negare l’esistenza stessa di un popolo palestinese) la prima donna primo ministro in Israele Golda Meir, salita al potere nel 1969.
La disfatta segnò il tramonto politico di Nasser, con l’Egitto che aveva perso buona parte della sua aeronautica (morirà nel 1970 ed il suo posto verrà preso da Anwar Sadat). La sconfitta ebbe delle conseguenze importanti anche sul fronte palestinese, non soltanto per via dell’aumento dei profughi. Consapevoli di non poter più fare affidamento sul mondo arabo per tutelare le loro ragioni, essi rafforzarono la loro organizzazione di riferimento (OLP, fondata nel 1964 dalla unione tra vari gruppi politici), alla cui guida salì nel 1969 Yassir Arafat, leader dell’ala maggioritaria Al Fatah (la giovane). I palestinesi optarono per le azioni terroristiche, scatenando una serie di attacchi ed attentati (tra i più noti quello a Monaco di Baviera contro gli atleti israeliani – 11 vittime – durante i giochi olimpici del 1972), finalizzate, come recitava un articolo dello statuto, poi abrogato dopo gli accordi di pace del 1993, alla distruzione di Israele. Si faceva così seguito all’incontro di Karthoum del 1967, in occasione del quale tutti i leader arabi avevano ribadito i loro tre “no”: no al riconoscimento dello stato ebraico, no alle trattative, no ad accordi di pace. Le incursioni prendevano avvio dalle basi giordane dell’OLP, e videro protagonisti i feddayn (combattenti) palestinesi. Israele reagì sferrando attacchi contro i campi profughi e le basi operative dei gruppi terroristi in Giordania, tanto da indurre il re Hussein (1970) a sferrare (settembre nero) un attacco contro le basi palestinesi, esasperato dalle rappresaglie di Tel Aviv e dalle azioni terroristi.
L’attacco provocò migliaia di morti e lo spostamento delle basi palestinesi in Libano. Lo scoppio del conflitto in quel paese (1975), acutizzato dalla lotta tra le diverse fazioni (cristiani, sunniti, sciiti), avrebbe visto l’intervento della stessa Israele nel 1982, prendendo di mira le basi palestinesi e costringendo l’OLP ad un ulteriore trasferimento in Tunisia (per la cronaca in Libano la situazione rimase esplosiva fino all’intervento siriano, seguito al ritiro dell’ONU nel 1984, che di fatto trasformò il paese in una sorta di protettorato). I palestinesi si ritrovavano una volta di più come un popolo senza patria; sulla carta godevano del sostegno del mondo arabo, in realtà quest’ultimo si preoccupava molto di più dei singoli interessi nazionali. Per esempio, nel caso della Giordania a pesare era il fatto che una larga fetta della sua popolazione fosse di origine palestinese, ma più in generale la vicenda diveniva un utile pretesto per perseguire i propri obiettivi (come nel caso di Nasser). Sadat il 6 ottobre 1973 sferrò (assieme alla Siria) un nuovo attacco, approfittando della festività ebraica dello Yom Kippur (di qui il nome del terzo conflitto), deciso a riprendersi il Sinai. Nonostante gli israeliani venissero colti di sorpresa, riuscirono ad organizzare una efficace controffensiva grazie agli aiuti americani. A livello propagandistico, gli egiziani poterono lo stesso rivendicare di aver lavato l’onta del ’67 e infranto il mito dell’inattaccabilità dello stato ebraico.
La guerra del Kippur ebbe dei risvolti internazionali molto importanti, perché gli stati arabi produttori di petrolio (riuniti nell’OPEC) lo usarono come pretesto per alzare moltissimo i costi del petrolio (cd. Shock petrolifero, i prezzi quadruplicarono) e svincolarsi dai tradizionali legami con le compagnie occidentali, dando avvio ad una delle più grandi crisi economiche ed energetiche della storia. La guerra del Kippur segnò, inoltre, un rovesciamento della politica egiziana verso Israele e verso gli americani. Sadat resosi conto che lo stato di guerra non era più sostenibile da un lato si allontanò dai sovietici, riavvicinandosi agli USA e dall’altro avviò un dialogo con lo stato ebraico, sfociato in una visita ufficiale del 1977, nel corso della quale il presidente egiziano avanzò la sua proposta di pace, accettata da Tel Aviv. L’accordo sarebbe stato firmato a Washington (Camp David) nel settembre 1978, grazie alla mediazione di Jimmy Carter.
L’Egitto recuperava la sovranità del Sinai, in cambio riconosceva (primo stato arabo a farlo) Israele ed avviava rapporti economici ufficiali. La decisione di Sadat provocherà la reazione degli arabi, che espelleranno l’Egitto dalla lega, mentre il presidente sarà assassinato al Cairo nell’ottobre 1981 per mano di integralisti islamici (al suo posto si insedierà Hosni Mubarak). Nel corso degli anni Ottanta la situazione in Medio Oriente ha registrato nuovi episodi di violenza ed attacchi reciproci tra israeliani e palestinesi. Va detto che a metà di quel decennio si manifestarono, però, le prime aperture al dialogo sia da parte palestinese che dei paesi arabi filoccidentali (Giordania ed Arabia Saudita), contrapposti agli stati che conservavano un atteggiamento di totale chiusura (Siria, Iraq, Libia). In sostanza, la proposta – tornado alla risoluzione ONU del 1947 – era quella di un ritiro dai territori occupati dopo la guerra dei sei giorni (Cisgiordania o West Bank), propedeutico alla nascita di uno stato palestinese, con Gerusalemme capitale di due entità politiche.
La dirigenza israeliana non ne volle sapere, soprattutto perché queste aree nel frattempo erano stato colonizzate dagli ebrei e la pressione sui governanti erano molto forte, trovando nel partito conservatore al potere (Likud) il proprio punto di riferimento. Di fronte all’atteggiamento di Tel Aviv, si scatenò una nuova ondata di violenze, avviata nel 1986 con la cosiddetta Intifada (risveglio), una serie di rivolte popolari (caratterizzate spesso dal lancio delle pietre verso i militari chiamati a reprimere le manifestazioni), che in un certo senso regalò alla causa palestinese una visibilità ed un’attenzione internazionali che le azioni terroristiche – al contrario – non le avevano mai riconosciuto. Un nuovo capitolo del conflitto arabo israeliano si apriva con la prima guerra del Golfo nel 1991, seguita all’invasione irachena del Kuwait. L’OLP si era schierato col dittatore Saddam Hussein, il quale per legittimare l’aggressione del piccolo emirato aveva fatto appello, tra l’altro, alla causa palestinese: un nuovo esempio di strumentalizzazione della vicenda.
Ciò nonostante, chiuso il conflitto, per iniziativa dell’Amministrazione statunitense fu convocata ad Oslo una conferenza di pace per tutto il Medio Oriente, alla quale furono invitati a prendere parte i rappresentanti israeliani, palestinesi e di tutti i paesi arabi. Un segnale di apertura venne dalle elezioni politiche in Israele del 1992, che portarono al potere la sinistra laburista guidata da Itzhak Rabin (ex militare, comandante dell’esercito ai tempi della guerra dei sei giorni e prima ancora eroe del conflitto del 1948), che bloccò nuovi insediamenti in Cisgiordania e si dichiarò disposta al negoziato, sulla base della formula territori in cambio di pace. Le trattative portarono nel 1993 ad un accordo siglato ad Oslo, col quale per la prima volta israeliani ed OLP si riconoscevano reciprocamente: questa ultima rinunciava alla distruzione dello stato ebraico come finalità istituzionale e Israele cessava di annoverare l’OLP tra le organizzazioni terroristiche. Il 13 settembre 1993 veniva firmato a Washington, alla presenza del presidente Bill Clinton, l’accordo di pace tra Rabin ed Arafat, col quale veniva sancita la nascita dell’autorità nazionale palestinese (ANP), con sede a Gerico, alla quale sarebbe stata affidata in via autonoma la gestione dei territori (Arafat ne divenne il primo presidente). Gli accordi, nelle intenzioni, dovevano essere funzionali alla nascita dello stato palestinese. In pratica la Cisgiordania sarebbe stata divise tre zone: A) a totale controllo palestinese (perlopiù le città arabe); B) a controllo misto israeliano-palestinese; C) a controllo israeliano.
Nella campagna elettorale del 2001 Ariel Sharon propose una diversa partizione, secondo la quale le zone B e C, assieme a Gaza, sarebbero dovute passare integralmente sotto il controllo palestinese. L’intesa fu però ostacolata dai rispettivi estremisti (coloni, nazionalisti, integralisti) e dall’ostilità di molti stati islamici (a cominciare da Siria ed Iran). La Giordania, invece, siglò con Israele un trattato sulla falsariga di quello con l’Egitto del 1978, seguita ultimamente da Marocco, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. Il clima ostile scatenò una nuova ondata di violenze ed attentati, che acutizzarono insicurezza e scetticismo verso gli accordi di pace. A febbraio 1994 un colono israeliano estremista fece una strage di palestinesi nella moschea di Hebron, in Cisgiordania, mentre il 4 novembre 1995 lo stato ebraico fu scioccato dall’attentato nel quale perse la vita il premier Rabin, per mano di un estremista ebraico. A maggio dell’anno seguente le elezioni politiche videro la vittoria della destra, guidata al nuovo premier Benjamin Netanyahu, fortemente critica verso il processo di pace: il nuovo primo ministro era notoriamente schierato su posizioni sioniste conservatrici e contrarie ad intese col mondo arabo. Nonostante ciò, le pressioni americane portarono alla firma di nuovi accordi tra israeliani e palestinesi, che prevedevano un rafforzamento dell’autogoverno in cambio di una più efficace lotta contro il terrorismo. Nel 1999 le nuove elezioni segnarono il ritorno al potere dei laburisti guidati da Ehud Barak, il che sembrava preludere a nuovi negoziati, dove si sarebbero risolti molti nodi, a cominciare dallo status di Gerusalemme. I nuovi negoziati erano patrocinati da Bill Clinton e si svolsero a Camp David. La pace sembrava, insomma, a portata di mano, quando un episodio apparentemente minore – la passeggiata del leader dell’ultradestra nazionalista Ariel Sharon (un altro ex militare, come molti leader politici) nella spianata delle moschee di Gerusalemme (fine settembre 2000) – scatenò la reazione palestinese verso un gesto percepito come volutamente provocatorio visto il luogo santo per i musulmani. Si moltiplicarono manifestazioni di protesta e nuovi attentati (cosiddetta seconda Intifada) che interessarono non soltanto il West Bank, ma molte città israeliane.
Questa volta, a differenza della prima ondata di proteste, il ricorso alla violenza si faceva molto più acceso, come la propaganda araba con ampio ricorso ai media e alle nuove tecnologie abbia promosso le azioni finalizzate all’indipendenza palestinese. Va aggiunto, come riportato nella lucida analisi di inizio millennio del professor Glenn Robinson (Indiana University), che le stesse premesse dello stato palestinese e dell’autorità nazionale erano molto fragili. Si trattava, difatti, di una costruzione priva di reale legittimazione popolare, nata più che altro per le esigenze della politica internazionale e senza che alle autorità arabe fosse attribuita una reale autonomia decisionale e finanziaria (le tasse, per esempio, venivano trasferite dallo stato ebraico); in parole povere, l’ANP finiva per andare incontro solo ai desiderata di Tel Aviv, creando una forte insofferenza e favorendo la crescita di movimenti estremisti.
A questo aggiungiamo che lo stato di guerra praticamente senza fine e le varie fasi di occupazione che si sono succedute hanno impedito l’avvio di una seria politica di sviluppo economico, incrementando disagio e povertà, all’origine di molte proteste popolari, cavalcate dalle fazioni più estremiste. A preoccupare ulteriormente la dirigenza ebraica era la consapevolezza dell’incidenza della popolazione di origine palestinese in Israele. Dai circa 150mila che non abbandonarono lo stato ebraico dopo l’indipendenza del ‘48 – nonostante pressioni e intimidazioni, esproprio di terre, discriminazioni, e via dicendo – grazie al notevole tasso di natalità (decisamente diverso da quello israeliano che al contrario è in costante flessione), ad inizio millennio i palestinesi sono divenuti un milione (quasi un quarto della popolazione dello Stato di Israele), un peso demografico del quale sarebbe difficile non tener conto.
Gli scontri ripresero, al pari delle dure repressioni israeliane. Approfittando del diffuso malcontento e delle prevaricazioni, emerse sempre di più il ruolo dell’ala estremista palestinese di Hamas (entusiasmo), forte del sostegno nelle fasce più povere, grazie anche all’attività socioassistenziale, che gli assicurava molti nuovi seguaci.
Va ricordato che il fronte palestinese, già in precedenza, era tutt’altro che unito al proprio interno. La rivalità storica tra le fazioni di Al Fatah e Hamas (ad esempio per il controllo delle forze di sicurezza), era state spesso acutizzate dagli stessi israeliani, sulla base del principio di romana memoria del divid et impera. In un certo senso si colloca in questo filone anche l’organizzazione del territorio (formalmente) sotto il controllo palestinese, che si presentava diviso ed a macchia di leopardo, frammentato da centinaia di posti di blocco israeliani (è la situazione di Gaza e Gerico ad esempio), oltretutto intercalato dai numerosi insediamenti ebraici e dalle città nuove (come Ariel).
Da quanto detto, possiamo affermare come non sia certo un caso se dei circa 12 milioni di palestinesi, solo un terzo viva nei territori occupati, dove tra crisi economica, discriminazioni di fatto, colonizzazioni ebraiche e regime militare la vita è tutt’altro che semplice. Clinton si spese fino all’ultimo giorno del suo mandato per raggiungere un accordo di pace, senza raggiungere l’obiettivo; del pari fallimentare il negoziato tra Siria ed Israele, basato sulla restituzione delle alture del Golan conquistate nel 1967. Nel 2001 Sharon che aveva scatenato la nuova ondata di violenze con la famosa “passeggiata” vinse le elezioni anticipate provocate dalla crisi, rinnegando molti dei negoziati in corso e disconoscendo Arafat come interlocutore, accusandolo di non aver fatto nulla per bloccare il dilagare del terrorismo, che pure il leader palestinese condannava.
A dissuadere il nuovo orientamento radicale dei dirigenti israeliani non servirono i tentativi di mediazione americani, la cui attenzione nel frattempo era stata sviata dalla guerra al terrorismo seguita all’11 settembre 2001 e dalla nuova crisi irachena. Nel 2002 Sharon avviò la costruzione della cosiddetta barriera difensiva, che praticamente tagliava fuori i palestinesi dal resto del paese, oltretutto coinvolgendo territori posti sotto la sovranità dell’autogoverno di Gerico. Solo nel 2005 si realizzava una svolta importante.
Il nuovo governo israeliano, composto da una coalizione di unità nazionale alla quale presero parte anche i laburisti di Shimon Peres (poi eletto alla presidenza della Repubblica) e guidato sempre da Sharon, decideva il ritiro delle truppe schierate nei territori ed uno stop ad ulteriori colonizzazioni ebraiche. Tra fine 2004 ed inizio 2006 scomparivano Arafat (ucciso da un tumore al sangue) e Sharon (reso invalido da un ictus, morirà nel 2014), ma il processo di pace continuava e le elezioni del marzo 2006 furono vinte dal partito di centro Ehud Olmert (dal nome di un ex premier), creato proprio da Sharon per contrastare le fazioni più estremiste e proseguire i negoziati. Per quanto alla guida dei palestinesi fosse subentrato il moderato Abu Mazen, a gennaio del 2006 in modo inatteso a vincere le elezioni per il rinnovo del parlamento palestinese fu la fazione estremista di Hamas, gettando nuove ombre sul processo di pace. Gli attentati, con tanto di lanci di missili dai territori palestinesi verso Israele e scontri tra le due parti si succedettero e solo nel 2008 gli USA riuscirono a riportare al tavolo dei negoziati tutte i contendenti.
Contemporaneamente nuovi scontri opposero Israele con i gruppi estremisti Hezbollah (partito di Dio), che avevano base in Libano ma erano sostenuti dall’Iran; alla battaglia fu posta fine solo con l’intervento di un contingente dell’ONU. A fine dicembre 2008 gli israeliani, dopo numerose incursioni ed attacchi contro i territori palestinesi e preceduta da una dura campagna di bombardamenti, procedettero all’occupazione della striscia di Gaza (3 gennaio 2009). Il 18 gennaio Hamas e gli israeliani firmarono la pace, avviando il ritiro dei militari.
La guerra non dichiarata aveva provocato, però, un migliaio di morti, solo in minima parte militanti di Hamas, mietendo vittime soprattutto tra i civili, oltre produrre una nuova devastazione in un territorio già duramente provato.
La cronaca di quest’ultimo decennio ci presenta un copione già visto. Fasi alterne di negoziati e scontri, ci portano fino ai giorni nostri con notizie di nuovi incidenti tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, accompagnati da lanci di missili da Gaza; il risultato sono centinaia di feriti e scambi reciproci di accuse di terrorismo e/o di violenze da crimini di guerra, con minacce di ulteriori ritorsioni. In definitiva, il conflitto arabo israeliano in generale, e quello israelopalestinese in particolare, affonda le proprie radici in fatti storici che abbiamo avuto modo di analizzare e che finora non c’è stata la forza (e forse la volontà) di risolvere.
Sarebbe sicuramente facile dare le colpe ai rispettivi estremismi: il premier è sempre Netanyahu, nonostante l’ondata di scandali per corruzione che lo hanno investito, mentre nel mondo palestinese, per quanto resti ferma la figura di Abu Mazen al vertice dell’ANP, si fa sempre più forte la posizione di Hamas. Non possiamo dimenticare, però, che a rimetterci sono sempre le popolazioni civili che divengono, ieri come oggi, bersaglio di azioni militari e terroristiche che danno voce ad un risentimento che non si è fatto molto per sopire, al di là dei più o meno fallimentari negoziati, che al massimo hanno offerto soluzioni di breve durata. Le potenze occidentali, come gli stati arabi, hanno a parole sempre dedicato grande attenzione alle criticità dell’area, in realtà si sono più che altro curate delle rispettive sfere di interesse ed influenza: abbiamo visto come storicamente i paesi arabi abbiano spesso utilizzato la “causa palestinese” come un vessillo per altre rivendicazioni ed in questo senso la fine, ormai quasi trentennale, della guerra fredda non ha modificato il quadro.
Gli insediamenti e l’occupazione del territorio palestinese non solo non si sono mai veramente arrestati dal 1967, ma hanno conosciuto una fase di nuova espansione, pure grazie all’appoggio dell’Amministrazione Trump, la quale ha totalmente rivisto la politica di mediazione di Obama, tra l’altro riconoscendo Gerusalemme come legittima capitale dello stato ebraico, riducendo i finanziamenti ai palestinesi e chiudendo l’ufficio OLP in America. Lo status internazionale della Palestina rimane avvolta dalla più assoluta incertezza ed il suo ipotetico territorio resta sottoposto ad un regime di occupazione militare: l’unico riconoscimento ottenuto, nonostante le reiterate richieste, è stato quello di membro UNESCO nel 2011 e di osservatore permanente ONU l’anno seguente.
Il 19 luglio 2018 la Knesset israeliana (il parlamento) ha approvato una legge che dichiara Israele come lo Stato nazionale del popolo ebraico: l’ebraico diviene l’unica lingua nazionale, mentre l’arabo viene declassato a idioma con uno “status speciale”. Il 26 giugno 2019 si apriva in Bahrein il seminario economico per la pace israelopalestinese voluto dagli USA, che in realtà non portò a nessun risultato concreto, a parte alcuni vaghi impegni, a causa di un clima di sostanziale sfiducia, che ha spinto gli stessi palestinesi a boicottare il forum. Il 10 settembre 2019, qualche giorno prima del secondo turno delle elezioni, il primo ministro Netanyahu annunciava, in caso di rielezione, l’intenzione di annettere tutti i territori arabi dove fossero presenti insediamenti israeliani. Va ricordato che Israele tra il 2019 ed il 2021 ha visto un susseguirsi di votazioni che non hanno restituito un quadro politico stabile ed una maggioranza ben definita, con una prevalenza delle forze conservatrici. Il 18 novembre 2019 il segretario di Stato USA Mike Pompeo ha annunciato la revisione della posizione degli Stati Uniti circa la presunta illegalità degli insediamenti israeliani in territorio palestinese, di fatto riconoscendone la non contrarietà al diritto internazionale.
Nel 2020 il quotidiano israeliano Haaretz (di orientamento progressista) ha pubblicato il cosiddetto piano Netanyahu-Gantz, di fatto un progetto per realizzare l’annessione della Valle del Giordano allo stato ebraico: il 23% della Cisgiordania, comprendente 40.000 ettari di terra palestinese privata, 12 villaggi arabi, con 13.500 abitanti. Gerico – sede dell’ANP – diverrebbe una sorta di enclave all’interno del territorio israeliano, dalla quale non si potrebbe entrare o uscire senza passare per i checkpoint israeliani. In altre parole, si legittimerebbe l’occupazione di fatto di quei territori, proponendo ai palestinesi la nascita di un loro stato ben più ridotto e limitato (oltretutto non contiguo) rispetto ai precedenti disegni politici.
L’accordo, sostenuto dall’amministrazione Trump, è stato duramente criticato e rifiutato dagli arabi. Per motivi opposti, è stato avversato anche dai coloni ebraici, che lo vedono come la negazione del progetto della Grande Israele: in pratica l’occupazione totale ed internazionalmente riconosciuta di tutti i territori che lo stato ebraico di fatto controlla dal 1967. Il neoeletto presidente Joe Biden ha annunciato il ripristino degli aiuti ai profughi palestinesi (150 milioni di dollari USA stanziati ad aprile 2021), pur senza mettere in discussione la sovranità israeliana su Gerusalemme, facendo generiche dichiarazioni sulla pace e sviluppo nella regione.
La pandemia di Covid-19 ha palesato le profonde divisioni e discriminazioni interne: basti dire che la campagna vaccinale, portata come esempio per il mondo intero, ha riguardato quasi esclusivamente i cittadini israeliani, tagliando fuori gli arabi (60 a 1 il rapporto percentuale). Teniamo conto che la colonizzazione israeliana dei territori strappati agli arabi dopo le diverse guerre riguarda oggi circa 700mila israeliani (contando sia Gerusalemme che il West Bank) su circa 9 milioni di abitanti: quale leader politico si metterebbe mai contro una simile forza? Ergo un accomodamento secondo la formula territori in cambio di pace e due stati sovrani sarebbe certo astrattamente possibile, ma la domanda deve essere se lo si voglia per davvero. Gli stessi orientamenti radicali, come gli atteggiamenti egoistici e discriminatori dei quali si è cercato di dare sommariamente conto, remano nella direzione esattamente opposta. La comunità internazionale, pur auspicando a parole un processo di pace, di fatto non fa nulla di concreto, al più schierandosi con la parte più confacente ai propri interessi strategici ed economici.
di Paolo Arigotti