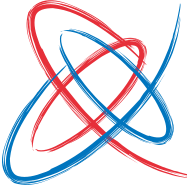Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, un contributo del Prof. Tedeschini (Amministrativista docente /co Università La Sapienza Roma) inviato a “Il Nuovo Panorama Sindacale”
La riforma della dirigenza pubblica bocciata dalla Corte Costituzionale, inascoltati i rilievi del Consiglio di Stato, dei giuristi e del sindacato.
Non serviva un grande intuito politico per immaginare che il procedimento legislativo afferente lo schema di decreto legislativo recante “disciplina della dirigenza della Repubblica” avrebbe avuto vita difficile, non solo per ragioni di ordine strettamente sindacale ma soprattutto per considerazioni di carattere giuridico.
A dar ragione ai numerosi critici di quello schema è pure intervenuto – in sede consultiva – il Consiglio di Stato, la cui Commissione all’uopo costituita ha reso un corposo parere (114 pagine) per illustrarne non solo la sostanziale incompatibilità di quello schema con il quadro costituzionale, ma anche l’assenza di alcune condizioni indefettibili per una riforma che il governo si ostina a voler attuare secondo linee portanti che violano innanzitutto il principio europeo dell’affidamento, inteso come quello secondo cui una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario: nella presente fattispecie il destinatario è ciascun dirigente pubblico e la relativa lezione si realizza nel momento in cui uno o più atti normativi vadano a pregiudicare la suddetta stabilità.
Sia chiaro, il Consiglio di Stato si è ben guardato dall’esaminare questo profilo – ed è sempre crescente il numero di giuristi che sottolineano l’assenza di sensibilità di quell’Organo verso le problematiche del diritto europeo – ma le critiche mosse a quell’atto normativo (correntemente indicato come “decreto Madia”) dimostrano che – anche a prescindere da qualunque concreto riferimento a quest’ultimo principio – difficilmente la proposta configurazione della nuova di disciplina della dirigenza potrà sopravvivere alle critiche mossegli finanche dal supremo organo consultivo della Repubblica.
Ma cosa, nella sostanza, avrebbe detto il Consiglio di Stato?
Ha innanzitutto espresso perplessità sulle modalità di inserimento della riforma nell’attuale quadro costituzionale, ove i rapporti fra politica e amministrazione sono stati profondamente ridisegnati rispetto all’originario modello francese, tutto imperniato sull’esasperazione del principio di gerarchia: ecco perché gli articoli 97 e 98 della Costituzione hanno introdotto la regola della piena autonomia gestionale dell’attività dirigenziale, escludendo la possibilità che chi è investito possa operare a favore di una determinata maggioranza politica.
Alla luce di questa regola – che assurge a dignità di principio generale del diritto – la giurisprudenza costituzionale ha più volte sottolineato come norme di legge che prevedano l’interruzione del rapporto di ufficio dei dirigenti per il sopravvenuto insediamento di un nuovo governo debbano “ritenersi contrarie al riportato quadro costituzionale” (v. Parere, pag. 9): ecco perché l’attuale modello di regolazione del rapporto fra i ministri e i loro direttori generali prevede una netta differenziazione funzionale tra attività gestionali e attività politiche, articolando la relativa disciplina – nella fase di costituzione del rapporto di servizio – con la stipulazione del relativo contratto e – in quella di costituzione del rapporto d’ufficio – con il conferimento del relativo incarico (v. Parere, pag. 18).
Lo stesso Consiglio di Stato insiste poi nel ricordare, in più punti, come la cessazione del rapporto d’ufficio in corso di svolgimento possa essere soltanto conseguenza di una accertata responsabilità dirigenziale, escludendo le altre possibilità invece previste nel decreto legislativo in esame.
Ulteriori e diverse critiche vengono mosse all’ipotesi di un ruolo unico nel quale far confluire dirigenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ricordando in particolare che la disciplina della dirigenza regionale deve sempre comunque adeguarsi alle regole di riparto delle funzioni legislative tra Stato e regioni come delineato dall’articolo 117 della Costituzione: ciò vuol dire che l’ipotesi del ruolo unico come delineato dal governo dovrà essere completamente ripensato se si vuole evitare la scure della Corte Costituzionale, più volte intervenuta nei confronti di quelle regioni che – dotatesi di una propria disciplina della dirigenza – hanno fatto mostra di dimenticare la distinzione fra profili di rilevanza negoziale (afferenti la materia dell’ordinamento civile, di competenza statale) e profili di rilevanza organizzativa (afferenti invece la materia dell’organizzazione di competenza regionale).
Ritiene infine il Consiglio di Stato che il repentino abbandono della disciplina attualmente in vigore possa comportare “l’oggettiva impossibilità di funzionamento di taluni meccanismi che presiedono alla nuova disciplina” e per l’effetto “ripercuotersi negativamente sulla stessa legittimità delle previsioni normative. Se, infatti, queste ultime, nella regolazione del rapporto di lavoro dirigenziale, devono essere conformi ai principi costituzionali, la loro possibile inattuazione si potrebbe risolvere in una violazione delle stesse disposizioni costituzionali, oltre che dei principi e dei criteri della legge delega” (v. Parere, pag.24).
La più radicale perplessità di quell’organo consultivo si appunta d’altronde sulla possibilità di rispettare il principio della invarianza di spesa, che sembra compromettere la fattibilità stessa della riforma, anche per il rischio – aggiungiamo noi – di un intervento repressivo della Commissione Europea. Viene altresì stigmatizzata l’insufficienza di precise regole che assicurino il funzionamento dell’ipotizzato mercato della dirigenza pubblica in un ambito nazionale di concorrenza tra dirigenti che si confronteranno per ottenere incarichi di durata troppo breve per definirsi ragionevole.
Quattro sono, in particolare, gli articoli del decreto su cui il Consiglio di Stato manifesta le maggiori perplessità: gli articoli 13 e 13 bis (qualifica dirigenziale e sistema della dirigenza pubblica) e gli articoli 28 e 28-bis (accesso alla dirigenza e corso-concorso).
Quanto ai primi osservando che la necessità di interpretare il nuovo assetto in modo conforme alla legge delega impone di non utilizzare quest’ultima come la base normativa per una reintroduzione, nella fase di organizzazione degli uffici, di differenziazioni interne all’unica qualifica, senza possibilità di rinvenire il proprio fondamento giustificativo nel principio di sussidiarietà legislativa; quanto ai secondi rilevando invece la scarsa chiarezza – ovvero la confusione – delle relative disposizioni a proposito del rapporto tra indizione del corso concorso e procedure di selezione dei dirigenti: questa sola circostanza fa dubitare il Consiglio di Stato della conformità della regolazione del sistema ai criteri dettati dalla legge delega.
Come si vede, ce n’è abbastanza perché il governo faccia riscrivere daccapo il decreto Madia, ma chi conosce il decisionismo del Presidente del Consiglio (si precisa che questo articolo è stato composto con Renzi ancora in carica, NdR) è portato a dubitare fortemente che questo possa accadere.
Si può dunque esser facili profeti nel prevedere che anche questa riforma darà luogo ad un lungo contenzioso, vuoi in sede nazionale che europea: a tutto svantaggio della tanto sbandierata nuova efficienza della pubblica amministrazione e del suo apparato dirigenziale.
Il prezzo di questo contenzioso lo pagheranno, come al solito, i cittadini.