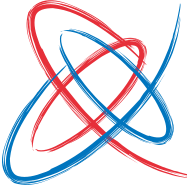Il processo di Norimberga è il nome convenzionalmente utilizzato – nei libri, negli spettacoli e nelle pellicole che se ne sono diffusamente occupati – per indicare due distinti procedimenti giudiziari, celebrati tra il 1945 e il 1946 nella città tedesca, rispettivamente contro un gruppo di 24 criminali di guerra (nelle persone dei leader superstiti del Terzo Reich) e altri 12 imputati “minori” (compresi i medici nazisti), più un secondo giudizio “secondario” che chiamò alla sbarra una serie di imputati “minori”, come ex magistrati o ex funzionari dello stato nazista. La decisione di imbastire il processo fu presa quando la guerra era ancora in corso, precisamente nell’autunno del 1943 durante la Conferenza a tre (USA – URSS – Regno Unito) tenutasi a Mosca, alla presenza dei ministri degli Esteri delle potenze alleate. Il processo avrebbe dovuto tenersi dopo la conclusione del conflitto, nel rispetto delle leggi del paese dove i crimini erano stati commessi. Nel timore che non tutti gli ordinamenti giuridici prevedessero talune fattispecie di reato, nella successiva conferenza di Teheran (che ebbe luogo a fine ’43) fu deciso che gli imputati sarebbero stati giudicati nel rispetto dei principi giuridici comuni alle nazioni civili e delle previsioni dei trattati internazionali sul diritto di guerra. Per quanto meno conosciuto in Occidente, un processo analogo fu celebrato a Tokyo (conclusosi nel 1948) contro la dirigenza giapponese, che determinò la condanna alla pena capitale o detentiva dei massimi responsabili politici e militari dell’impero del Sol Levante in tempo di guerra. Oggi, però, non siamo qui per parlare di questi importanti fatti storici, magari ci torneremo in un’altra occasione. Non vogliamo, difatti, parlarvi dei processi che sono stati celebrati, bensì di uno che non è mai iniziato: quello contro i responsabili di analoghe imputazioni (parliamo di crimini di guerra, contro la pace e contro l’umanità) che si sarebbe – almeno nelle intenzioni degli alleati – dovuto promuovere contro personaggi di nazionalità italiana. Occorre sul punto fare un’importante premessa. Partiamo dalla constatazione che la narrazione nostrana del dopoguerra, compresa quella fatta dai libri e dai film, per lunghissimo tempo non si è neanche lontanamente occupata dei fatti illeciti imputabili ai nostri connazionali, veicolando semmai l’immagine dell’italiano “buono”, paragonato al tedesco “cattivo”. Sia ben chiaro che non parliamo di un processo contro un’intera nazione o un intero popolo, neppure quelli di Norimberga o di Tokyo avevano questa pretesa; a parte l’improponibilità stessa di una simile opzione, ci riferiamo casomai a giudizi contro singole personalità, investite di importanti responsabilità politiche o militari, e che in tale veste si macchiarono di fatti gravissimi e penalmente rilevanti. Fare un elenco di questi crimini sarebbe molto lungo, richiederebbe probabilmente un programma a parte: ci limiteremo pertanto a qualche rapido cenno, giusto per capire di cosa parliamo. Procediamo in ordine di tempo e partiamo dalla campagna di Libia (condotta tra il 1921 e il 1932): per quanto colonia italiana dal 1912, il territorio africano non era mai stato del tutto soggiogato e permanevano importanti sacche di resistenza, specie da parte di alcune frange degli autoctoni (i senussi, in particolare): la campagna di “normalizzazione” della colonia fu portata avanti con inaudita ferocia dal governatore, Maresciallo Pietro Badoglio (futuro capo del governo) e dal comandante militare delle operazioni generale (poi Maresciallo) Rodolfo Graziani: qui ovviamente siamo costretti a riassumere, ma parliamo di decisioni e scelte che causarono centinaia di migliaia di deportati, la creazione di campi di concentramento, violenze e abusi di ogni genere ai danni dei civili, esecuzioni sommarie senza processo di migliaia di ribelli (o presunti tali). Lo stesso Graziani lo ritroviamo, pochi anni dopo, in Etiopia, come comandante militare prima e governatore della nuova colonia poi, quando il fascismo decise di sferrare l’attacco e conquistare una delle due sole nazioni africane allora indipendenti (l’altra era la Liberia). Pure in questo caso – sia prima che dopo il conflitto militare – l’elenco dei crimini, in spregio a ogni convenzione internazionale sul diritto di guerra, sarebbe lungo: bombardamenti sui civili, utilizzo massiccio di armi proibite (come i gas), campi di concentramento, stragi spesso immotivate (come quella del febbraio 1937, a danno di civili inermi, in occasione del quale perirono, a seconda delle fonti, tra le 4 e le 30mila persone). Lo scoppio del conflitto mondiale creerà nuovi teatri di guerra e la consumazione di ulteriori crimini ai danni di cittadini comuni (sotto forma di deportazioni, violenze, campi di concentramento, uccisioni sommarie), consumati in Slovenia, Croazia, Montenegro e Grecia, secondo linee di azione suffragate (e incoraggiate) dai più alti comandi politici (Mussolini) e militari (vedasi la figura del generale Mario Roatta, in particolare per i fatti commessi nella neonata provincia di Lubiana). I criminali di guerra italiani si contarono, alla fine della guerra, in circa un migliaio di persone, mentre per le vittime nei Balcani si parlerà di 100mila civili deportati e migliaia di vittime (compreso il dieci per cento degli abitanti di Lubiana). Questa brevissima panoramica, oltre ad infrangere il mito degli italiani “brava gente”, tanto caro nel dopoguerra alla filmografia e pubblicistica nazionale, rende efficacemente l’idea di quanto questa credenza fosse destituita di ogni fondamento; parlando dell’emersione dei fatti in Africa, un grandissimo merito va tributato al lavoro allo studioso Angelo Del Boca, mentre per i crimini consumati nei Balcani e in Grecia molto resta ancora da indagare (almeno in Italia). A questo punto nasce spontaneo l’interrogativo: come e perché nel nostro paese, annoverata tra le nazioni sconfitte in guerra, non fu celebrato un processo contro i responsabili di crimini tanto numerosi quanto efferati? Si potrebbe replicare che gli italiani non pianificarono mai genocidi su larga scala, paragonabili a quelli commessi dai nazisti nell’Europa orientale o dai giapponesi in Asia, il che non sminuisce però la rilevanza penale di una lista molto lunga di crimini e dei loro presunti responsabili. La risposta, come sempre, non è univoca e investe profili politici. Occorre calarsi nella realtà del dopo guerra e nelle condizioni generali, sia interna che internazionale. Uno degli argomenti a discarico che va per la maggiore sarebbe rappresentato dall’armistizio dell’8 settembre 1943, con il quale l’Italia, dopo aver esautorato con un colpo di mano Mussolini e il Fascismo (dichiarando ipocritamente che la guerra continuava), si arrese agli alleati; il governo Badoglio, rifugiatosi nel sud Italia – assieme al sovrano – per scampare alla più che probabile vendetta tedesca, dichiarò poco dopo guerra all’ex alleato nazista, vedendosi riconosciuto lo status di co-belligerante (al nord, nella parte occupata dalle truppe di Hitler, nasceva nel mentre lo stato fantoccio della RSI). In sostanza, la nazione si sarebbe così riscattata, pure grazie alla lotta partigiana di resistenza, la quale, per la verità, ebbe un ruolo più che altro simbolico, visto che l’Italia fu liberata solo per effetto dell’avanzata alleata. Questa argomentazione, molto inflazionata, non appare affatto decisiva, tenuto conto che molti dei potenziali imputati di crimini di guerra (per esempio Graziani, nominato ministro delle forze armate della RSI) non si erano certo affatto arresi, anzi. Non è questione che possiamo affrontare oggi, ma scaricare solo sui tedeschi molti degli indubbi e ingiustificabili crimini commessi nell’Italia occupata dopo l’armistizio vorrebbe dire dimenticare il ruolo – magari minoritario, ma che pur sempre ci fu – avuto dalle milizie repubblichine, che non solo cooperarono coi tedeschi, pure nel rastrellamento degli ebrei, ma che assunsero nella lotta antipartigiana iniziative autonome e molto violente. Non si deve, ad ogni modo, pensare che l’ipotesi di una “Norimberga italiana” sia stata liquidata sbrigativamente: commissioni alleate, in particolare composte da britannici, investigarono nel nostro paese per individuare e chiamare alla sbarra i responsabili dei crimini di guerra prima ancora della fine del conflitto, solo che alla fine non se ne fece nulla. Una certa influenza la ebbe il referendum istituzionale del 2 giugno, preceduto dalle prime elezioni amministrative indette in Italia nella primavera del 1946, che scatenarono il timore, specialmente britannico, che la celebrazione di un processo contro i capi politici e militari avrebbe acutizzato il risentimento popolare (confermato dalla sconfitta della monarchia del 2 giugno) e favorito un incremento dei voti per le sinistre. Molto più di questo, però, contarono i fatti del dopo guerra. Si allungava l’ombra della guerra fredda e l’Italia era inserita – sulla base degli accordi di Yalta – nella sfera occidentale. Per effetto di tale collocazione nel nuovo scacchiere mondiale, il nostro paese era in netta contrapposizione rispetto alla Iugoslavia socialista di Tito, uno dei primi paesi a sollevare la questione dei crimini nostrani, all’epoca ancora nell’orbita sovietica. Era chiaro che le richieste di un paese potenzialmente nemico non potevano trovare accoglimento. Ciò detto, suona quasi paradossale che una importante decisione politica al riguardo fosse assunta dal ministro della Giustizia del PCI, il leader del partito Palmiro Togliatti, che diede il suo nome a quello che potremmo considerare il primo “colpo di spugna” della storia repubblicana. Fu proprio lui ad apporre la sua firma – ovviamente secondo una decisione condivisa con l’intero governo di coalizione (composto da democristiani e socialisti) – sul decreto col quale, il 22 giugno 1946, praticamente all’indomani del referendum istituzionale che sancì la fine della monarchia, veniva approvata un’amnistia (cd. Amnistia Togliatti) la quale, con l’intento di raggiungere la pacificazione nazionale, di fatto condonava tutti i reati comuni e politici (compreso il concorso in omicidio e collaborazionismo) commessi dopo l’armistizio e fino al 18 giugno 1946, col solo limite di una pena massima di 5 anni. All’origine del provvedimento, la consapevolezza che in troppi erano stati i fiancheggiatori del regime, per cui attuare l’epurazione totale auspicata dai più integralisti sarebbe stato praticamente impossibile, se non controproducente. Chiaramente i più gravi reati, come genocidio o violenza ai danni dei civili, non era condonati, ma due successivi provvedimenti varati dal Governo Pella (1953) e poi in data 4 giugno 1966 cancellarono tutti i reati politici consumati prima del giugno 1948. Chiaramente il legislatore italiano non era competente ad intervenire su reati commessi all’estero contro cittadini di altre nazionalità (è il caso dell’Africa o dei Balcani), ragion per cui l’amnistia non frenò le richieste di estradizione avanzate da vari governi (Iugoslavia, Grecia, Etiopia), che caddero nel vuoto in spregio agli accordi internazionali che pure le contemplavano. Nel caso iugoslavo, oltre alla situazione politica che abbiamo delineato, soccorse una interpretazione sfruttata da Roma e fondata sul principio di reciprocità, all’epoca previsto dall’ordinamento penale militare di guerra: in pratica se Belgrado avesse voluto processare i nostri connazionali, lo stesso trattamento avrebbe dovuto essere riservato agli iugoslavi per i crimini commessi contro gli italiani (pensiamo al discorso delle foibe e più in generale ai fatti in danno degli italiani in Istria e Venezia Giulia). Caddero del pari nel vuoto le richieste di greci ed etiopi. L’Italia, è vero, si incaricò di imbastire processi contro i suoi stessi cittadini (pur violando così l’art. 38 del trattato di pace, che prevedeva tutto il contrario), è il caso di Roatta o di Graziani, come di altri personaggi di spicco del passato regime (Buffarini Guidi, Koch, Valerio Borghese, solo per fare alcuni nomi), solo che tali iniziative non ebbero un esito significativo; per la cronaca Badoglio non fu mai processato. Unico atto politico di rilievo, adottato solo nel 2013, fu l’istituzione di una “Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti”, inerente quasi 700 fascicoli rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi (sede della procura generale militare di Roma), circa una serie di crimini risalenti alla Seconda guerra mondiale; va detto che, pure in tal caso, le indagini non hanno restituito esiti. Sia Graziani (che pure fu processato e condannato) che Roatta (la cui estradizione fu ripetutamente chiesta dagli iugoslavi e che trovò rifugio per diversi anni nella Spagna franchista) beneficiarono dei provvedimenti di condono, morendo in condizione di libertà a Roma, rispettivamente nel 1955 e nel 1968. Ci sia consentito concludere con le parole di uno storico – il prof. Michele Battini – che, nel libro dal quale abbiamo preso spunto, afferma come nel dopoguerra (non solo in Italia) fu “elaborata una memoria selettiva e parziale, basata sull’esclusiva attribuzione dei crimini contro l’umanità alla nazione tedesca, identificata col nazionalsocialismo.” Come dire, tutti gli altri – italiani compresi – venivano assolti senza processo. In effetti, quando i processi sono stati celebrati, talvolta molto tardivamente, gli imputati non erano italiani, quasi a voler ulteriormente confermare l’idea del tedesco malvagio: è il caso dei processi contro Kesserling (1947) e – dopo decenni di silenzio, sembra per non turbare le relazioni italo tedesche – quello contro Erich Priebke (1996), i quali offrono, in tal senso, una interessante chiave di lettura. Ci possiamo, forse, “consolare” con scelte non molto dissimili compiute in Austria (ne parleremo in futuro), nella Francia del dopo Vichy (pure su questo faremo un approfondimento) o, per venire a tempi più vicini, a quanto avvenuto nei paesi sudamericani o dell’est europeo dopo la caduta dei vari regimi autoritari. Praticamente ovunque la tendenza è stata quella della rimozione, della riconciliazione, dell’amnesia collettiva, e quando i processi si sono celebrati hanno avuto un’efficacia assai dubbia, a voler essere ottimisti molto parziale.
di Paolo Arigotti